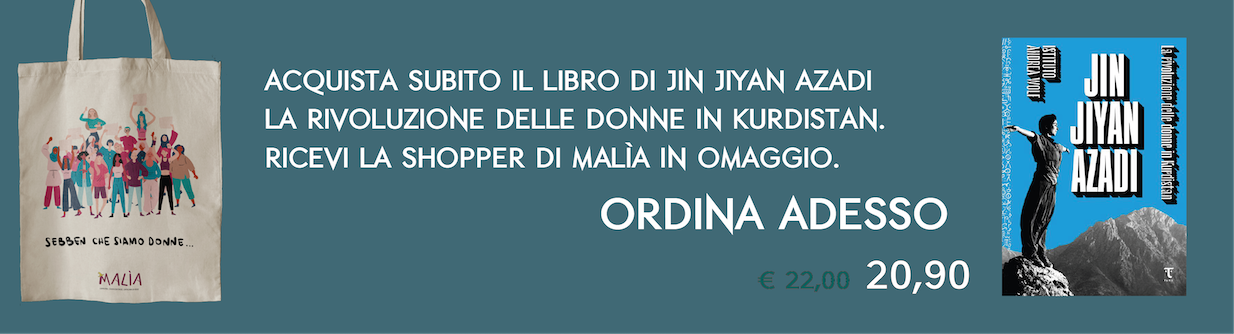di Valeria Cagnazzo*
Chi di noi due sa a chi apparteniamo?
Noi, con questa nostra faccia rugosa, a te?
O tu, amante di strade senza ritorno, a noi?
O piuttosto, è al boia che apparteniamo entrambi, oh Baghdad?
Quando Fawzi Karim abbandonò l’Iraq per la prima volta, era il 1970. Nato nel 1945, figlio di un droghiere, aveva già pubblicato la sua raccolta d’esordio, “Dove iniziano le cose”, ed era stato il poeta più giovane a partecipare alla prima Conferenza Internazionale di Poesia a Baghdad nel 1966. Insegnava letteratura in una scuola superiore, ma fu deposto dal suo incarico per sospette simpatie comuniste e fu costretto a rifugiarsi in Libano all’ascesa del partito Ba’th.

Fawzi Karim
La rinascita che seguì al colpo di stato del 14 luglio del 1958 non durò, infatti, a lungo. Il Consiglio della Sovranità che prese il controllo della neonata Repubblica varò senz’altro delle riforme rivoluzionarie, in campo economico, a favore delle classi più disagiate, come nell’ambito dei diritti civili, promuovendo un’educazione paritaria, vietando i matrimoni con spose bambine e il ripudio arbitrario della moglie. Ma le spaccature ideologiche e i personalismi dei tre membri del Consiglio, ciascuno incapace di raccogliere sufficienti consensi dalla società civile, emersero presto. I rapporti diplomatici stretti con Cina e Unione Sovietica e la riappropriazione del controllo statale su gran parte dei giacimenti petroliferi, fino a quel momento sfruttati dall’IPC (Iraq Petroleum Company) britannica, peggiorarono drasticamente le relazioni della repubblica irachena con i Paesi occidentali. Nel 1964, approfittando di una fase di instabilità politica, il giovane partito Ba’th con un colpo di Stato rovesciò il governo del primo ministro Kassem. Seguirono epurazioni ed esecuzioni massive; ville, stadi e scuole furono riconvertiti in campi di concentramento e prigioni per gli oppositori: una di queste strutture era il Qasr al-Nihaya, che significa “Palazzo della Fine”. I vertici dei partiti di opposizione furono in pochissimi giorni tutti trucidati o arrestati, i bersagli principali del partito erano i comunisti . Il sunnita ‘Arif, ex membro insieme a Kassem (già giustiziato arbitrariamente) del Consiglio della Sovranità, riuscì dopo alcuni mesi ad estromettere dal governo i ba’thisti e a instaurare un regime militare: alcuni ba’thisti furono condannati al carcere, ma gran parte dei sunniti del partito, tra i quali Saddam Hussein, grazie alle loro amicizie nell’esercito furono graziati. Ebbero quindi modo di riorganizzare il Ba’th. In un periodo di crisi per la politica interna ed estera irachene, con un nuovo golpe i bathisti presero definitivamente il potere nel 1968. Il presidente era Ahmad Hasan al-Bakr e il suo vice, responsabile anche dei servizi segreti, Saddam Hussein.
Grazie alla nazionalizzazione completa delle risorse petrolifere, lo Stato baathista assicurò all’Iraq un rinnovamento economico che abbatté i livelli di disoccupazione e assicurò drastici miglioramenti nella qualità della vita degli iracheni, con il crollo dei tassi di mortalità infantile e l’allungamento della vita media. Iniziò a quel punto la baathizzazione del Paese. La società irachena fu riorganizzata in formazioni baathiste. Le organizzazioni indipendenti furono dichiarate illegali, i dissidenti arrestati. Per tutte le famiglie, il partito disponeva di un dossier in costante aggiornamento. Chi non aderiva a Ba’th, veniva deposto dagli incarichi pubblici.
Un esempio di questa epurazione è proprio Fawzi Karim. Dopo l’esperienza in Libano provò a rientrare nel suo Paese fino al 1978, anno della sua partenza, definitiva, per l’Inghilterra. L’emigrazione fu sempre vissuta da Karim come un doloroso esilio politico. L’Iraq divenne la terra negata, quella del gelso e dell’oleandro del suo giardino, della sua infanzia, di suo padre. L’incontro con la patria idealizzata è possibile solo nella poesia, una sorta di interregno onirico. Il confine tra il Paese dell’esilio e l’Iraq rassomiglia a quello tra la terra e la vita ultraterrena: il poeta lo attraversa in versi, ma ogni volta emerge chiaramente come sia impossibile per lui appartenere pienamente alla realtà e alle sofferenze sia dell’una che dell’altra.
Lo spaesamento e la solitudine dell’esiliato sono temi costanti nella sua poesia, ma lo stile piano, le scelte lessicali, l’intrusione persistente della quotidianità, denunciano la contaminazione della sua scrittura con la poesia del vecchio continente. La sua produzione è instancabile, oltre ventitré libri di poesia, tra cui “Dell’esilio e della conoscenza” (1972) e “Alzo le mani per protesta” (1973), e poi saggi critici e un romanzo. Ma la condanna alla nostalgia e alla vita in un Paese straniero lo tormenterà fino alla morte.
Le stelle si spengono sotto i miei passi mentre mi avvio verso le cime delle palme,
cercando tra i rami spinosi, nei suoi nidi, l’uovo dell’impossibile.
Divido il pane con gli uccelli
che si avviano all’esilio, coi pesci che
si avviano alla sorgente, con l’angelo che
si avvia con passi incerti.
Vedo creature con vesti su cui germoglia la vite e mani ricolme di calici,
le odo cantare all’alba,
magari l’alba col loro canto aprisse una finestra sull’aldilà.
Costretto alla fuga fu anche Jabbar Yassin Hussin. Nato a Baghdad nel 1954, iniziò a militare nel Partito comunista all’età di quattordici anni, nel 1968, dopo il colpo di stato ba’thista. Era incaricato di attività clandestine come trasmettere le comunicazioni tra i membri del Comitato Centrale, portare in tipografia testi e foto da stampare, diffondere le informazioni provenienti dal Kurdistan o dal Libano. Poi si trasferì nei quartieri operai: “Vivevo nei quartieri più poveri di Baghdad, dove famiglie di venti persone vivevano ammassate in una stanza. Per me, che provenivo dalla media borghesia, questo era motivo di orgoglio”. Tra i fondatori e leader della Gioventù Comunista, torturato e arrestato più volte, rassegnò le dimissioni quando nel 1973 il suo partito, o ciò che ne restava, confluì nel Ba’th per formare il Fronte Nazionale Progressista. Fu bandito dall’Università e dal giornalismo. Continuò a scrivere di tutto, poesie, racconti, favole per bambini, finché le continue minacce non lo costrinsero definitivamente a lasciare il suo Paese per la Francia con un passaporto falso: era il 1976.
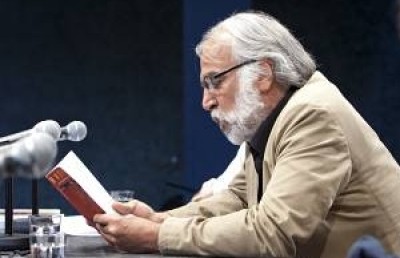
Jabbar Yassin Hussin
In Francia, il poeta divenne un clochard. Aveva duecento dollari in tasca, una lettera di un membro del vecchio Partito Comunista Iracheno per un uomo che non avrebbe mai trovato e una borsa con cinque libri. Vagò a lungo come senzatetto nelle strade di Parigi, una volta alla settimana si metteva in fila in una struttura pubblica della cittadella universitaria per fare una doccia, il resto del tempo lo passava attraversando le campagne per cercare lavoretti come bracciante. Era questo il poeta che avrebbe pubblicato tredici libri, tra i quali, tradotti anche in italiano, “Nel mio paese d’argilla”, “Addio bambino”, “Sogno di Baghdad”, “Il lettore di Baghdad”, raccolte di poesie come “Un cielo oscuro di stelle” e “Terra dell’oblio”, e che sarebbe stato proposto dallo scrittore Gabriel Garcia Marquez al Nobel per la Letteratura. L’Iraq rimase al centro di tutta la sua produzione, prendendo la forma di ricordo, rêverie, di allucinazione in preda alla febbre, o di donna.
La sera, venne a trovarci Um Ali, la vicina. (…) Come se recitasse la preghiera della sera, si mise a raccontare la storia di Mu’aydiyya. “La ragazza e suo padre possedevano dei bufali. Un giorno l’inglese la vide e se ne innamorò follemente. Alcune settimane dopo, la rapì ai suoi genitori e la sposò dopo averla condotta nel suo paese. Laggiù dipinse il suo ritratto. La sua bellezza proverbiale era conosciuta da tutti gli inglesi. Questo però non le impediva di languire lontano dalla sua famiglia e dall’odore dei bufali. Sopportava così male il suo esilio in casa degli inglesi, in un paradiso, con servitori e un seguito, che finì con l’ammalarsi. I medici non seppero cosa fare per guarirla. Morì, lontana dai suoi, e di lei all’inglese rimase solo il ritratto. (…) Chi muore in terra altrui, muore solo. Solo, senza lutto, senza sudario né feretro.”
Nel 1978 Saddam, sempre al vertice dei servizi segreti e vicepresidente del Consiglio del comando rivoluzionario, stilò una lista nera di autori proibiti. Tra questi Virginia Woolf, Dostoevskij, Sartre, e il poeta iracheno Nabeel Yasin.

Nabil Yassin
Un timbro rosso, a destra della foto che mostrava un volto giovane, imberbe, con una piccola fossetta a tagliargli il mento, capelli mossi, folti, marchiò proprio in quell’anno anche il passaporto di Yasin con la scritta “Enemy of the state”. In clandestinità, Yasin fu costretto a lasciare l’Iraq. Nato nel 1950, Nabeel Yasin si era laureato in letteratura araba e già da giovanissimo si era consacrato alla scrittura, come giornalista e come poeta. Con la dittatura di Saddam Hussein, per la sua famiglia iniziarono le persecuzioni. I suoi due fratelli maggiori, un nazionalista e un comunista, furono arrestati e torturati. Un altro fratello, più piccolo, venne presto mandato come soldato sul confine con l’Iran. Una sorella, che era medico, fu costretta a lavorare negli ospedali più piccoli e poveri del Paese dal momento che si era rifiutata di iscriversi al Partito baathista. La colpa di Nabeel Yasin risiedeva nella sua scrittura, e nella sua volontà di continuare a scrivere liberamente, a ogni costo. Fu sua madre, mentre la famiglia si disgregava in preda alle violenze del regime, a dirgli “Scrivere è il tuo dovere”, e ancora “Qualsiasi cosa tu pensi del mondo, non puoi sprecare la vita nell’ostilità verso di esso. Pensa a quali cose vorresti cambiare, e poi parla. Ma prima di farlo, pensa se ne vale la pena”. Nel 1973, Nabeel Yasin compose “I poeti satirizzano il re”. Il regime considerò l’opera un attacco diretto a Saddam: per due anni impedì la pubblicazione della raccolta, che fu poi stampata, censurata, nel ’75. L’edizione originale, tuttavia, iniziò segretamente a circolare, ad essere letta e recitata negli ambienti di opposizione. Si declamava “Brother Yasin”, di nascosto, e nelle stanze del governo si preparava la sentenza di condanna a morte del poeta.
Sono l’ultimo miserabile uomo saggio in un Paese che detesta gli uomini saggi,
Sono l’ultimo a stringere le braci ardenti mentre il fuoco brucia,
sono l’ultimo a bruciare.
Nell’inverno del 1978, Yasin fuggì in clandestinità insieme alla moglie Nada e al loro figlioletto di tre anni. In esilio, scrisse, come in atto di sfida, “Brother Yasin again”.
Cos’ho da offrire, Yasin?
Non la mia libertà,
schiavizzato fino alle ossa da un Iraq infedele,
lo nutro con sollievo e conforto,
mi ripaga con merda e zaknabout*.
Percorrendo la strada verso la mia famiglia
Vedevo riflettersi nelle acque dell’Eufrate
gli occhi degli annegati,
brillavano come stelle,
e in cima alle palme, stelle morte
che spargevano cenere sull’argine del fiume
E in piedi io ancora disegno aeroplani sui corpi dei morti,
tiro giù i loro occhi perché possano servire da rifugio alle farfalle,
che ci si nascondano al mattino, dopo aver rubato gocce di rugiada a un fiore.
* “zaknabout” è un termine del dialetto iracheno usato per indicare qualcosa di particolarmente spiacevole al gusto o pericoloso da ingerire, anche in senso figurato, traducibile con “veleno”.
Un anno dopo la fuga di Yasin, il Presidente Ahmad Hasan al-Bakr si dimise per motivi di salute. Nel 1979 il suo successore Saddam Hussein prendeva quindi pieni poteri sull’Iraq: diventava il capo dello Stato totalitario, il “rais” del Paese.
La fama della storia del poeta, o della sua leggenda, si è diffusa in Inghilterra, la patria finale del suo esilio, forse più della sua poesia. Su Nabeel Yasin è stato girato per Al Jazeera English un breve documentario, “The poet of Baghdad”, disponibile in rete, e la giornalista freelance Jo Tatchell ha pubblicato “Nabeel’s song”, opera biografica sul poeta. Qui si legge della sua infanzia, della sua famiglia e degli anni lontano dal suo Paese natìo. Si ritrovano anche dei piccoli aneddoti molto emblematici della funzione che la poesia può ambire a ricoprire nella società, e dell’importanza politica ed esistenziale, probabilmente al di sopra di ogni aspettativa da parte di chi scrive, che in tempi di guerra o di dittatura può arrivare a ricoprire per i singoli e per la collettività.
“Alla fine, dovrei ringraziare quei teppisti baathisti. Dovrei celebrare la mia prigionia nelle carceri baathiste. E sa perché? Mi ha offerto il dono più meraviglioso – l’opportunità di mettermi adesso in contatto con lei”. A scrivere quest’email al poeta fu il soldato semplice Abdul Karim Kadum. Mandato sul fronte al confine con l’Iran, portò con sé il suo libro preferito, “I poeti satirizzano il re”. Mentre i suoi compagni morivano e saltavano sulle mine, quelle poesie erano il suo unico rifugio. Mentre i soldati del suo battaglione pregavano, lui recitava quei versi, le pagine si consumavano sotto alle sue dita avide, nell’umidità e nel fango dell’accampamento. Un giorno che era lontano dalla sua tenda, un comandante insospettito dai comportamenti di Kadum andò a frugare sotto alle sue coperte: vi trovò il volume messo nell’indice dei libri proibiti da Saddam. Abdul Karim Kadum fu rinchiuso in un carcere militare, condannato a dieci anni. Fu molto tempo dopo, deposta la dittatura, che riuscì a mettersi in contatto con il suo poeta preferito: l’ammirazione e la devozione per lui erano immutate.
Per tutta la durata della dittatura di Saddam, i versi di “Brother Yasin” furono tramandati a memoria o diffusi in fotocopie, segretamente. Al suo ritorno in Iraq dopo ventisette anni di esilio, Yasin avrebbe incontrato ragazzi iracheni capaci di recitargli quella poesia dal primo all’ultimo verso senza una sola incertezza, pur non essendo assolutamente in grado di riconoscere nel suo volto invecchiato e nei suoi folti capelli canuti l’autore ormai leggendario che tre decenni prima l’aveva composta. Pagine Esteri
BIBLIOGRAFIA
“Plague Lands and other poems”, Fawzi Karim, Carcanet press, 2011, traduzione in italiano da Pina Piccolo. versione inglese di Anthony Howelll, dalla traduzione dall’arabo di Abbas Kadhim.
“Storie di giorno, racconti di notte” Jabbar Hassin Yussin, Argo editore, Lecce 2005
“Nabeel’s song: a family story of survival in Iraq”, Jo Tatchell, Doubleday, 2007
“Breve storia dell’Iraq”, Thabut A.J. Abdullah, Il Mulino, 2012
SITOGRAFIA
Documentario “The poet of Baghdad”: https://www.aljazeera.com/program/artscape/2011/7/3/the-poet-of-baghdad
Poesie inedite Fawzi Karim http://www.lamacchinasognante.com/
Clicca qui per leggere la prima parte di “Iraq dei poeti”
*Valeria Cagnazzo (Galatina, 1993) è medico in formazione specialistica in Pediatria a Bologna. Come medico volontario è stata in Grecia, Libano ed Etiopia. Ha scritto di Palestina su agenzie online, tra cui Nena News Agency, anche sotto pseudonimo. Sue poesie sono comparse nella plaquette “Quando un letto si svuota in questa stanza” per il progetto “Le parole necessarie”, nella rivista “Poesia” (Crocetti editore) e su alcune riviste online. Ha collaborato con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna. Per la sezione inediti, nel 2018 ha vinto il premio di poesia “Elena Violani Landi” dell’Università di Bologna e il premio “Le stanze del Tempo” della Fondazione Claudi, mediante il quale nel 2019 ha pubblicato la sua prima silloge poetica, “Inondazioni” (Capire Editore). Nel 2020, il libro è stato selezionato nella triade finalista del premio “Pordenone legge – I poeti di vent’anni”.