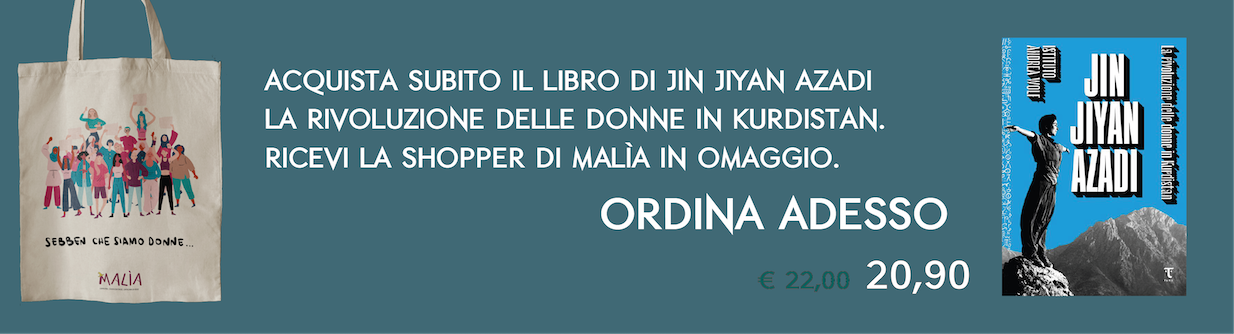di Valeria Cagnazzo*
Pagine Esteri, 1 settembre 2021 – Le sentinelle erano i bambini. Venivano lasciati in giardino a giocare e quando vedevano gli uomini della polizia religiosa affacciarsi sulla strada, entravano ad avvisare le loro mamme, che prontamente mettevano via i libri di Keats, Shakespeare, Dostoevskij e li sostituivano con ago e filo, ricami e uncinetti. È così che la scuola femminile di cucito “L’ago d’oro” riuscì a sopravvivere sotto il governo talebano a Herat. Erano gli anni ’90 e alle donne era stata vietata qualsiasi forma di istruzione, pubblica o privata. Poche attività erano considerate lecite per le afghane, tra queste il cucito. Tre volte alla settimana, le ragazze del circolo dell’Ago d’Oro si riunivano, quindi, ufficialmente per partecipare a lezioni di sartoria: i pomeriggi si trasformavano, invece, in incontri clandestini in cui i professori dell’università di Herat tenevano conferenze di letteratura e in cui le allieve potevano leggere i testi a loro proibiti e confrontarsi in dibattiti sullo stile e sulla metrica della poesia internazionale e contemporanea. Se i Talebani le avessero scoperte, avrebbero torturato e poi appeso per il collo prima i docenti e poi quelle giovani studentesse camuffate da apprendiste sarte, ma la lettura e la scrittura, evidentemente, valevano anche quel rischio capitale. Le voci vivaci dei bambini intorno al palazzo erano la loro unica protezione, finché fuori si giocava le donne erano al sicuro. In quelle lezioni segrete, una giovane Nadia Anjuman, allora sedicenne, colpì per il suo talento artistico il mentore del circolo, il professore di letteratura Muhammad Ali Rayhab. Fu lui a incoraggiarla a scrivere versi, a confrontarsi con altri poeti dell’epoca, a elaborare il suo stile, a maturare insomma il sogno di diventare una poetessa, come quelli che leggeva tre pomeriggi a settimana a costo della vita.

Qualche anno dopo, nel 2005, proprio una lettura in pubblico di alcuni suoi versi, pubblicati nel frattempo in due raccolte, fu probabilmente il pretesto per un litigio tra Nadia e il marito, Farid Ahmad Majid Neia, che la uccise letteralmente di botte. Era il 4 novembre, Nadia non aveva ancora compiuto venticinque anni e lasciava orfana una figlia di sei mesi. Il marito, che era un ricercatore della Facoltà di Lettere di Herat, confessò di aver picchiato Nadia ma dichiarò che la sua morte sarebbe stata causata da un infarto o da un avvelenamento compiuto dalla stessa nel tentativo di suicidarsi. Secondo quanto sostenuto da Neia, la colluttazione sarebbe derivata dal suo divieto alla moglie di far visita ad alcuni parenti; secondo la famiglia di Nadia da tempo la sua attività poetica era considerata scomoda dal coniuge e dai suoi genitori. La poetessa era già morta quando fu condotta in ospedale. Secondo i medici, a provocarne il decesso sarebbe stato un danno cerebrale conseguente a un trauma cranico riportato durante le percosse: la famiglia del marito Neia si oppose all’autopsia sul corpo della vittima. Anche le Nazioni Unite intervennero per condannare l’omicidio, e Neia fu arrestato. Ma i capi tribali del distretto di Herat convinsero il padre di Nadia a perdonare pubblicamente il genero: in cambio gli assicurarono che l’uomo sarebbe rimasto in carcere per almeno cinque anni. Grazie al ritiro della denuncia da parte della famiglia di Nadia, il tribunale attribuì la morte dell’artista a un suicidio e scagionò Neia dopo solo un mese di detenzione. L’uomo fu in breve riabilitato al suo lavoro accademico in Università. Il padre di Nadia morì poco dopo per lo shock provocato dal rilascio anticipato di Neia e per il senso di colpa, stando a quanto dichiarato dal fratello della poetessa.

“Il Paese peggiore per nascere donna”, da troppi decenni l’Afghanistan è legato a questa definizione euripidea. Herat, detta anche “la città dei poeti”, è tra le cittadine con il più alto tasso di femminicidi nel Paese. È difficile identificare delle stime attendibili sui crimini compiuti contro le donne, data la ridotta percentuale di quelli che vengono effettivamente denunciati. Nonostante il miglioramento delle condizioni della donna a partire dal 2001, però, appare evidente, e la morte di Nadia Anjuman ne è un esempio, come vent’anni di occupazione occidentale non abbiano risolto il problema della discriminazione di genere in Afghanistan. Solo nel 2020, appena un anno prima che le truppe della coalizione abbandonassero l’area, le uccisioni di donne denunciate, secondo la Commissione Indipendente Afghana per i Diritti Umani, sarebbero state almeno 100: tutti processi sciolti senza arrivare alla condanna di un colpevole. Ciononostante, le pressioni occidentali, in particolare di diverse ONG, hanno in parte contribuito a un progresso nel dibattito sui diritti della donna e sulla riforma del sistema giuridico per tutelarli. Un traguardo è stato, ad esempio, la legge sull’Eliminazione della Violenza sulle Donne nel 2009, in un Paese in cui gli stupri e gli uxoricidi erano questioni private all’ordine del giorno da risolvere tra le pareti domestiche. Se nel 2004, tra l’altro, nella nuova Costituzione afghana, è stato incluso un articolo, il 22, che stabiliva che donne e uomini sono uguali davanti alla legge, dall’altro canto nei due decenni successivi qualsiasi spinta egualitaria è stata frenata dai suoi detrattori, impugnando un altro articolo della stessa Costituzione, il 3, che dichiara: “Nessuna legge può contravvenire ai principi e alle disposizioni della sacra religione dell’Islam in Afghanistan”. L’approvazione della legge sull’Eliminazione della Violenza sulle Donne del 2009, poi riconfermata nel 2018 da Hamid Karzai, è stata pertanto un evento rivoluzionario: essa criminalizzava per la prima volta non solo lo stupro o il matrimonio forzato, ma anche l’interdizione della donna dall’attività lavorativa o dall’educazione. Come riconosciuto da diverse ONG e avvocati afghani e internazionali, tuttavia, bastava (l’imperfetto è purtroppo oramai d’obbligo, data la trasformazione attualmente in corso nel Paese) spostarsi nelle aree rurali o nelle periferie, perché la legge non fosse riconosciuta, e perché gli stessi giudici locali la considerassero anti-islamica o un’emanazione dell’occupazione occidentale. Se fosse stata approvata qualche anno prima, resta da chiedersi quindi se sarebbe stata sufficiente a garantire una giustizia più rigorosa per l’omicidio di Nadia Anjuman.

Non è sulla sua morte, tuttavia, che bisogna concentrarsi quando si parla di un poeta. La storia di Nadia Anjuman è soprattutto un esempio di incrollabile fiducia nella parola. Il sogno della scrittura fu coltivato tenacemente, dalle letture clandestine dell’Ago d’Oro sino alla pubblicazione delle sue poesie. Quando il regime talebano cadde, infatti, Anjuman fu finalmente libera di proseguire gli studi che fino a quel momento le erano stati negati: si iscrisse alla facoltà di Lettere di Herat nel 2001 stesso e si laureò appena un anno dopo. Pubblicò due raccolte: “Fiori di fumo” e “Un fiore rosso scuro”. Non aveva ancora sposato Neia, il ricercatore di Lettere, quando concluse il suo secondo libro. In Italia, le sue poesie sono raccolte in Elegia per Nadia Anjuman a cura di Ines Scarparolo e Cristina Contilli, edizioni Carta e Penna.

“Nacqui a Harat negli anni più agghiaccianti della rivoluzione; portai a termine i miei studi in anticipo, di due anni, nella scuola superiore Mahbubeh haravi. Attualmente frequento il secondo anno della facoltà di Letterature e Scienze Umanistiche dell’Università di Herat. Da quando ho memoria di me so di aver amato la poesia”, scrive Anjuman di sé, in una nota autobiografica. “L’amore per la poesia e le catene di sei anni di schiavitù dell’era dei Talebani, che mi avevano legato le gambe, hanno fatto sì che appoggiandomi alla penna e zoppicando, componessi passi ed entrassi nel territorio della poesia. Il sostegno dei miei amici e di coloro che condividevano i miei stessi orizzonti mi hanno permesso di continuare su questo sentiero, ma, ahimè, tuttora, ogniqualvolta che compongo un nuovo passo, sento il tremore della mia penna e con essa trema anche la mia anima. Forse perché non mi sento indenne, temo ancora di sdrucciolarmi lungo il percorso; è difficile la strada che ho davanti a me… ed i miei passi non sono ancora, abbastanza, fermi”.
I passi che Anjuman muove nel territorio della poesia provengono dall’infanzia, da un amore atavico per la scrittura, ma trovano la loro ragion d’essere anche nella schiavitù patita, nel dolore inflitto dai Talebani, che dopo il 2001 può essere, o almeno sembra, finalmente esternato, condiviso con gli agognati lettori. Di fatto tutta la produzione della Anjuman è votata alla denuncia, al lamento, e non può essere in nessun momento scorporata dal suo essere una donna afghana in una fase storica di incerta transizione.
Quante volte è stata tolta dalle labbra
la mia canzone e quante volte è stato
azzittito il sussurro del mio spirito poetico!
Il significato della gioia è stato
sepolto dalla febbre della tristezza.
Se con i miei versi tu notassi una luce:
questa sarebbe il frutto delle mie profonde immaginazioni.
La fine dell’oppressione talebana e l’arrivo delle truppe straniere non sono, del resto, accolti con acritica speranza. Anzi, la poesia di Anjuman sembra negare o negata alla speranza. L’ottimismo è raramente abbozzato in qualche frammento, quasi fosse un esercizio di stile. Per tutto il resto della sua produzione, la poetessa sembra godere nel pungolare ogni suo asciutto verso con un’amarezza diaristica lacerante, che quasi sembra tingersi, a posteriori, delle tinte di un tetro presentimento.

Le mie lacrime non sono servite a niente
e non mi rimane altro che la speranza.
Nonostante io sia figlia della città della poesia,
i miei versi furono mediocri.
La mia opera è come una pianta priva di cure,
da cui non si può pretendere molto.
Nell’archivio della storia,
questo è tutto ciò che mi rappresenta.
È probabilmente per una vocazione romantica, nutrita nei pomeriggi all’Ago d’Oro, che le lacrime, secondo la Anjuman, dovrebbero “servire” a qualcosa, se si è un poeta. Il sacrificio della religione musulmana e l’ostinazione eroica di Byron fusi nel corpo minuto di Nadia Anjuman. Se l’integralismo raggiunge il suo obiettivo di omologazione femminile quando l’immaginario collettivo guarda alle donne afghane come a una massa di corpi identici intrappolati da un burqa e da un’identica, e per tutte allo stesso modo muta, disperazione, la voce di Anjuman spezza questo pregiudizio e frastorna, con l’esperienza soggettiva, personale di dolore di chi antepone a tutto la poesia. Le donne dell’Ago d’Oro sfidavano la morte per la letteratura. Anche quando è finalmente libera di scrivere, la vita sotto il burqa come quella senza per lei trovano un senso solo quando possono essere raccontate da una poesia che sia alla loro altezza – che sia all’altezza, insomma, sia del dolore più indicibile che della speranza. “Tu puoi dire tutto questo? Posso”, è il verso dell’Achmatova che meglio cristallizza la poetica di tanta letteratura contemporanea, in particolare di quella cosiddetta “civile”. La poesia di Anjuman pare costantemente interrogarsi su quel “posso”, sulla sua capacità di essere cronista delle sofferenze delle donne afghane: non essere in grado di narrarle, quella sarebbe la vera disperazione, la perdita di qualsiasi senso dell’esser nata donna e afghana con la passione per la scrittura.
Nessuna voglia di parlare.
Che cosa dovrei cantare?
Io, che sono odiata dalla vita.
Non c’è nessuna differenza tra cantare e non cantare.
Perché dovrei parlare di dolcezza?
Quando sento l’amarezza.
L’oppressore si diletta.
Ha battuto la mia bocca.
Non ho un compagno nella vita.
Per chi posso essere dolce?
Non c’è nessuna differenza tra parlare, ridere,
Morire, esistere.
Soltanto io e la mia forzata solitudine
Insieme al dispiacere e alla tristezza.
Sono nata per il nulla.
La mia bocca dovrebbe essere sigillata.
Oh, il mio cuore, lo sapete, è la sorgente.
Sono poesie piuttosto semplici e lineari, ed è con semplicità a volte sconcertante che viene spesso riferita la violenza morale o fisica subita dagli uomini, come un fatto quasi scontato, un elemento da rendicontare, da riferire con tono piano, che provoca sì dolore ma senza scatenare drammi. “Ha battuto la mia bocca”, scrive, riferendosi a una violenza probabilmente subita troppe volte, per la sua ostinazione a scrivere, a parlare. “La mia bocca dovrebbe essere sigillata”, dalla sua piccola storia personale diventa eco del pensiero di tutte le donne ugualmente battute. Ma non sprofonda mai nella disperazione, il suo compito è continuare a scrivere. “L’animo si riempie del suo essere vuoto, come l’abbondanza di una carestia”, scrive ancora, come se la sua missione ultima fosse quella di ripartire in versi al mondo quell’abbondanza maturata e sofferta sotto a uno scafandro azzurro da un intero popolo. È tale consapevolezza del ruolo della poesia che fa grande questa giovane poetessa ai più sconosciuta, il suo sacrificio commovente in nome della letteratura. D’altronde, come il fratello ha raccontato, gli anni in cui era finalmente libera di studiare Lettere furono quelli più felici della vita di Nadia, quelli in cui ai familiari sembrava animata dalla convinzione di poter possedere il mondo intero nelle mani. Quest’immagine forse potrebbe aiutare a comprendere meglio le donne afghane, in questo periodo in cui se ne torna a parlare, a individuarne la forza e le battaglie singolari nell’immagine orizzontalmente propinata dai media di tutti gli schieramenti di vittime eterne senza un volto. La loro storia nella storia. La storia di Anjuman, poetessa, che aiuta a riconoscere in quella massa azzurra senza occhi la possibilità che si creino nuovi circoli di cucito e di resistenza segreti, dove nuove poetesse e scrittrici dell’Ago d’Oro sappiano ingannare l’oppressore e siano disposte a dare la vita per la passione di scrivere.
Sono stata silenziosa troppo a lungo.
Ma non ho dimenticato la melodia,
Perché ogni istante bisbiglio le canzoni del mio cuore
Ricordando a me stessa il giorno in cui romperò la gabbia
Per volare via da questa solitudine
E cantare come una persona malinconica.
Io non sono un debole pioppo
Scosso dal vento
Io sono una donna afgana
Ha senso solo lamentarsi.
Elegia per Nadia Anjuman – Carta e Penna, 2021
*Valeria Cagnazzo (Galatina, 1993) è medico in formazione specialistica in Pediatria a Bologna. Come medico volontario è stata in Grecia, Libano ed Etiopia. Ha scritto di Palestina su agenzie online, tra cui Nena News Agency. Sue poesie sono comparse nella plaquette “Quando un letto si svuota in questa stanza” per il progetto “Le parole necessarie”, nella rivista “Poesia” (Crocetti editore) e su alcune riviste online. Ha collaborato con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna. Per la sezione inediti, nel 2018 ha vinto il premio di poesia “Elena Violani Landi” dell’Università di Bologna e il premio “Le stanze del Tempo” della Fondazione Claudi, mediante il quale nel 2019 ha pubblicato la sua prima silloge poetica, “Inondazioni” (Capire Editore). Nel 2020, il libro è stato selezionato nella triade finalista del premio “Pordenone legge – I poeti di vent’anni”.