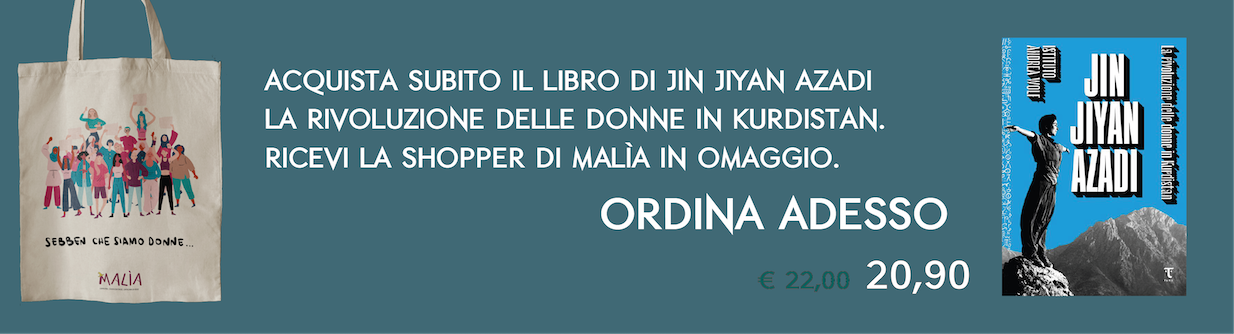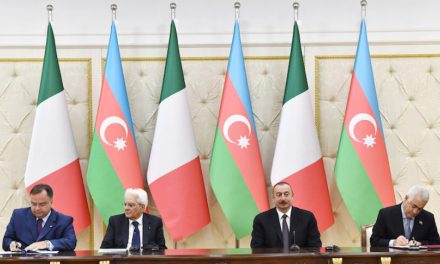di Caterina Maggi*
Pagine Esteri, 14 gennaio 2022 – “Sono l’orgogliosa figlia di mia madre/ non abbasserò la mia voce” è il testo di una canzone riportato in un reel di sensibilizzazione dell’attivista e cantante Shina Nova, che ha raggiunto dieci milioni e mezzo di visualizzazioni (cioè quasi sei volte i suoi 1,7 milioni di seguaci). La particolarità? Shina Nova, figlia d’arte di un’altra cantante Kayuula Nova, è (come la madre) una ragazza inuk cioè un’appartenente al popolo Inuit, il gruppo etnico nativo dislocato in Canada e parzialmente nella zona Nord degli Stati Uniti. Gli Inuit, insieme ai “cugini” Yupik, costituiscono la grande famiglia dei gruppi etnici autoctoni delle fredde aree settentrionali del pianeta. E sono stati, come altri gruppi indigeni, vittima di un olocausto collaudato e feroce da parte dei colonizzatori coevi e successivi alle scoperte di Colombo. Il video di Shina Nova è un messaggio di denuncia contro un’aggressione verbale subìta, da parte di una persona che le ha detto che avrebbe “preso uno straccio per cancellare quei segni”. I segni in questione sono i tatuaggi tradizionali, che Shina ha deciso di farsi imprimere sul volto in un atto di amore per le proprie origini. Il reel ha velocemente raggiunto milioni di utenti e raccolto solidarietà in tutto il mondo.
Relegati in riserve come carceri a cielo aperto, in territori ridotti al lumicino non solo dalla segregazione, ma anche da attività ambigue legate all’estrazione petrolifera (come la famigerata Coastal Gaslink CGL), i nativi hanno saputo però sfruttare uno strumento “white biased” come un “cavallo di Troia” perfetto, raggiungendo milioni di persone e riuscendo a sensibilizzare non solo l’opinione pubblica canadese (e in parte statunitense) ma anche quella del vecchio continente, permettendo tra l’altro agli attivisti delle minoranze etniche europee di “venire alla luce”. Si tratta dei social network, costruiti da bianchi per altri bianchi e spesso responsabili di censura e “adombramento” (shadow ban in inglese) sia nei confronti degli indigeni americani sia nei confronti di altre comunità in protesta (lgbtq+, minoranze di Medio ed Estremo Oriente etc.). Il movimento LandBack e l’Orange Day diventano virali, anche attraverso sketch brevi che diffondono approfondimenti e musica alternativa in lingua mista o nativa.
Shina Nova, come altr* attivist* indigen*, utilizza in larga maggioranza Instagram e TikTok, due social di largo uso tra giovani e giovanissimi di due generazioni, la Generazione Z e i Millenials, più permeabili e suscettibili a temi come la preservazione dell’ambiente (della cui conservazione d’altronde i nativi di tutto il mondo sono responsabili per oltre il 70%) il riscaldamento climatico e le lotte delle minoranze etniche nel mondo. A differenza delle precedenti generazioni non vive il trauma delle scuole residenziali, gli istituti statali di “rieducazione” dei nativi dove veniva chiusi i bambini indigeni a partire dai 4 anni e che restarono operativi fino agli anni ’90 (l’ultima scuola Kivalliq Hall chiuse nel 1996). In questi edifici, si stima, sarebbero morti a causa delle durissime condizioni a cui erano sottoposti più di 4 mila bambini ma il bilancio è estremamente provvisorio, visto che nuove fosse comuni vengono ritrovate quasi ogni mese e molti bambini non hanno ricevuto una sepoltura. Se le scuole hanno chiuso, e ora l’opinione pubblica canadese si sta mobilitando per fare chiarezza e restituire pace alle vittime e ai survivors di questa tragedia, molto resta da fare sul fronte delle riserve – 634 quelle censite in Canada – trasformate in ghetti a cielo aperto dove i nativi sono costretti in condizioni degradanti e dove, spesso, possono contare solo sulla mutua solidarietà.

Negli empori delle comunità, tra dazi e restrizioni, il costo dei prodotti di prima necessità come quelli alimentari può arrivare a costare anche 6/7 volte di più di quello fuori dalle riserve, causando uno stato di insicurezza alimentare che affligge il 70 % di questi centri. Shina documenta tutto e ripropone i temi in reels che non servono solo a sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche a raccogliere fondi per le comunità. Come quelli che hanno permesso quest’estate di donare ai bambini della comunità di Shina Nova biciclette nuove. L’obbiettivo di 20 mila dollari è stato ampliamente superato e ha permesso a Shina e sua madre di fare anche una cospicua donazione al rifugio per donne della zona.
Nelle Hawaii invece la protesta va a passo di danza (sacra). Sui profili Instagram di attivisti italiani focalizzati su questi temi si è diffuso velocemente il reel di Mele Maikalani, un’isolana di 19 anni che ha iniziato a parlare su Youtube di tradizioni hawaiiane e di come la cultura colonizzatrice si sia appropriata di diversi aspetti del folklore isolano, banalizzandolo o ridicolizzandolo. La hula, ad esempio, nata come danza sacra ma diventata un mezzo (spesso usato da compagnie di viaggi e imprenditori non autoctoni) per attrarre i turisti. E proprio i turisti sono la causa dell’impoverimento non solo della biodiversità locale ma anche della varietà culturale di Polinesia e Micronesia. Gli arrivi nelle Hawaii per viaggi turistici, nonostante la pandemia, sarebbero stati 5.789.948 secondo il sito ufficiale dello Stato delle Hawaii. Con un impatto fortissimo su un ecosistema già danneggiato dall’antropizzazione che, spesso, è proprio operata per costruire resort e altre strutture a beneficio dei visitatori. Diversi sono i problemi causati dai vacanzieri: dalla profanazione dei luoghi sacri per scattare qualche selfie a una vera e propria penuria di acqua, sull’isola di Maui, dove le autorità hanno obbligato la popolazione autoctona a non usare l’acqua se non per “uso essenziale”; peccato che la preziosa risorsa non fosse stata prosciugata dagli isolani, ma da hotel e resort, dove pochi controlli sono stati fatti in merito e che hanno accolto nel 2021 quasi 2 milioni di turisti.
L’11 dicembre del 2020 Kohala Corporation e KP Holdings LLCil presentano al Dipartimento per la salvaguardia ambientale hawaiano il progetto di un parcheggio, comprensivo di un’area ristoro, nell’area sacra della Valle di Polulu sull’isola di Kapauu; del progetto non vengono nemmeno informati gli indigeni presenti nel posto. L’area è un wahi pana, un sito sia religioso che di memoria storica, ma il piano edilizio non cita l’importanza culturale ma solo lo straordinario panorama. Mele decide di sostenere la causa di chi vuole preservare la Valle di Polulu, prende il telefono e fa quello che fanno (e guardano) milioni di suoi coetanei in tutto il pianeta: registra un reel chiamando a raccolta il popolo del web per firmare una petizione e sostenere il movimento ecologista. Il video raggiunge più di 400 mila visualizzazioni, mentre le firme raccolte dalla petizione su Change.org sono oltre 878 mila.
Ci sono mille altri esempi che si potrebbero fare di attivist* per i diritti nativi, sia autocton* che alleat*, sparsi in tutto il mondo. Se questi movimenti sopravviveranno alle censure e ai pochi controlli sulla Gig economy, e se i social sapranno dare sostegno alle loro battaglie, non è ancora certo. Ma restituisce fiducia pensare che una donazione, in qualsiasi parte del mondo, può restituire a chi viveva da prima in un territorio oggi minacciato dignità e benessere. Pagine Esteri
 *Laureata in Lettere all’Università di Genova e diplomanda alla Scuola di Giornalismo di Bologna, giornalista praticante presso l’Istituto Affari Internazionali, si appassionata fin da giovanissima alla questione palestinese e al Medio oriente. Scrive per il sito online Affarinternazionali.
*Laureata in Lettere all’Università di Genova e diplomanda alla Scuola di Giornalismo di Bologna, giornalista praticante presso l’Istituto Affari Internazionali, si appassionata fin da giovanissima alla questione palestinese e al Medio oriente. Scrive per il sito online Affarinternazionali.