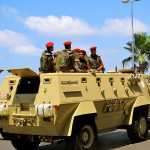A cura del Collettivo Zenobia –
Pagine Esteri, 5 agosto 2023. A quasi un anno dall’ultima incursione delle forze israeliane negli uffici di Al-Haq a Ramallah, si conclude la nona edizione della “Applied International Law Summer School” organizzata dalla Ong palestinese nella West Bank.
Dal momento della sua designazione da parte israeliana, nell’ottobre del 2021, quale organizzazione terroristica – sulla base di accuse mai comprovate, come hanno avuto modo di osservare diversi paesi dell’Unione europea tra i quali l’Italia – Al-Haq non ha mai mancato l’appuntamento iniziato nel 2015. Ogni anno, da metà a fine giugno, decine di studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo, attivisti dei diritti umani e persone impegnate in differenti gradi e forme a sostegno della causa palestinese, hanno l’opportunità di verificare sul campo l’importante lavoro che questa e le altre Ong incontrate nel corso del programma portano avanti.
Un lavoro meticoloso, di documentazione e di sostegno legale, che facilita la ricomposizione delle tante frammentate esperienze di resistenza del popolo palestinese e scava tra le crepe di un sistema che, dal 1948, riproduce una “Nakba continua” e strutturale.
Risalire il corso delle crepe, arrivare al cuore della falla: per comprendere il senso dell’operato di Al-Haq, e il suo contesto, vogliamo ripercorrere alcune delle tappe più significative del programma della Scuola.

Due allevatori della comunità beduina su cui insiste la fabbrica di Mishor Adumim, nella Valle del Giordano. Foto di Collettivo Zenobia
Natura e vite sfruttate: la Valle del Giordano
Attraversando quest’ampia distesa di terra arsa dal sole, assale la sfacciata presenza delle architetture dell’occupazione che l’Ong palestinese documenta da decenni: tubazioni serpeggianti, gigantesche fabbriche avvolte nella polvere e insediamenti come Kalya, famosa per le spiagge che si affacciano sul Mar Morto e per i datteri delle sue aziende agricole.
In nessun’altra zona della West Bank è più evidente l’esproprio di risorse naturali realizzato dalle grandi e medie compagnie israeliane ai danni della popolazione palestinese: dall’acqua, estratta e redistribuita dalla società Mekorot, che dal 1982 detiene il monopolio sulle riserve idriche cisgiordane e ne gestisce l’allocazione, profondamente diseguale sia nelle quantità che nei costi, tra le colonie israeliane e le comunità palestinesi, alle riserve minerarie, la cui estrazione produce nugoli di polveri inquinanti nelle terre popolate da comunità beduine; alla forza lavoro.
Il report pubblicato nel 2022 dall’Ufficio centrale di statistica palestinese mostra come il mercato del lavoro israeliano, entro i confini ufficiali dello Stato e nelle colonie, rappresenti la seconda fonte di impiego per i palestinesi della Cisgiordania. Un dato che aiuta ad interpretare il ricatto che i lavoratori delle piantagioni di palme da datteri di Kalya subiscono ogni giorno, dove donne e bambini, come ha denunciato Human Rights Watch nel 2015, sono impiegati in condizioni di sfruttamento e sottopagati.
L’altro aspetto del ricatto del mercato del lavoro israeliano è il prezzo concorrenziale con cui i diversi attori israeliani riescono a rivendere, spesso alla stessa popolazione palestinese, ciò che viene prodotto da manodopera a basso costo e senza diritti (o importato con tariffe doganali irrisorie rispetto a quelle cui sono soggetti i beni importati in Palestina).
Dalla negazione dell’accesso alle risorse naturali allo sfruttamento e al ricatto lavorativo, la colonizzazione sionista si muove sul doppio binario della sistematica espulsione e dello scacco socio-economico che consente a Israele di prosperare ed espandersi con l’acqua e il sudore dei palestinesi.

Gli impianti della fabbrica di Geshuri visti dall’azienda agricola palestinese di Hakoritna, a Tulkarem. Foto di Collettivo Zenobia
Auto-organizzarsi contro l’inquinamento: area industriale di Geshuri, Tulkarem
La storia della fabbrica di Geshuri e della famiglia di agricoltori di Hakoritna può aiutarci ad inquadrare una seconda crepa nella quale si inserisce il lavoro di Al-Haq. Nel corso di tutta la visita non smette mai di accompagnarci il respiro tossico degli impianti di produzione di componenti chimiche per pesticidi e fertilizzanti, impianti originariamente collocati nella parte israeliana dei confini del 1948. Nel 1987, in seguito alle continue proteste dei residenti indignati dalle condizioni di inquinamento da essa prodotte, la fabbrica è stata delocalizzata sul versante cisgiordano: in pochi anni, le famiglie del posto hanno visto aumentare significativamente il tasso di tumori e disturbi respiratori tra i propri membri- come ha documentato Lancet in un report del 2013.
A pochi metri di distanza dalle ciminiere, al riparo dei capannoni della fattoria di Hakoritna crescono cetrioli, pomodori e ortaggi coltivati rigorosamente secondo agricoltura biologica, le tecniche e i benefici della quale sono oggetto di varie iniziative in cui la famiglia proprietaria della fattoria coinvolge la comunità locale. L’acqua è ricavata da meccanismi di filtraggio della pioggia e accumulata in alcune cisterne ai quattro angoli della serra; l’elettricità è prodotta grazie ai pannelli solari che sono sul tetto. Dal governo palestinese la fattoria ha ricevuto poco più di qualche incoraggiamento.
Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato dal Palestinian Center for Policy and Survey Research, oltre l’80% della popolazione palestinese ritiene che l’Autorità nazionale, i cui rappresentanti sono stati eletti l’ultima volta nel 2006, sia corrotta e distante dai bisogni delle persone, collusa con Israele in materia di sicurezza e ad esso subordinata sul piano economico. Di fronte a questa situazione, reale e percepita, le tante forme di auto-organizzazione produttiva diventano pilastri fondamentali per il sostentamento e lo sviluppo sociale (per quanto relativo, per via della limitazione e negazione dell’accesso alle risorse naturali imposte dall’occupante) delle comunità palestinesi, che riescono così ad affrancarsi dalla morsa di un mercato del lavoro quasi completamente dipendente da Israele.
Il lavoro che Al-Haq porta avanti, di documentazione e di sostegno legale presso le corti internazionali di realtà come la fattoria Hakoritna o come le aziende agricole palestinesi nella Valle del Giordano, serve a riunificare queste esperienze – frammentate non solo geograficamente dalle infrastrutture dell’occupazione, ma anche sul piano della narrazione – favorendone la rappresentazione in uno stesso quadro.
Ghettizzazione e gentrificazione: Gerusalemme est
Qual è questo quadro? Per rispondere vogliamo ripercorrere un’ultima tappa del programma della Summer School: quella che ci ha portati ad osservare come a Gerusalemme est l’apartheid sistematico dei palestinesi si riproduca seguendo tre direttrici fondamentali.
Una prima direttrice è la ghettizzazione, nella forma della reclusione delle famiglie dei rifugiati dalle espulsioni del ’48 in campi come quello di Shu’fat che ospita anche tante coppie discriminate dalla Legge contro l’unificazione familiare e palestinesi che non possono affrontare i costi sempre più elevati delle case in città. O in quartieri come Kufr Aqab, ufficialmente parte della municipalità della Città santa, ma tagliato fuori da essa dal checkpoint di Qalandiya, uno dei più grandi e tristemente noti per l’alto numero di vittime delle forze israeliane. In entrambi questi casi, la maggior parte della popolazione residente sceglie di abitare in aree asfissianti per l’addensamento di abitazioni, altamente insalubri e insicure per via dell’abbandono e della marginalizzazione, perché è l’unico modo per non perdere la cittadinanza gerusalemita: il risultato, come riporta JLAC nel report del 2022, è la concentrazione di oltre il 33% della popolazione palestinese di Gerusalemme est in circa il 4% della superficie totale di questa parte della città.
Intervengono, poi, operazioni di esproprio ed espulsione che riproducono in una grande area metropolitana quanto avviene nel resto della West Bank: è il caso di Sheikh Jarrah o dell’area di Silwan, o del “Piano E1” pensato per collegare Gerusalemme est con la colonia di Ma’aleh Adumim con un sistema di strade, parchi commerciali e servizi turistici. Interventi che mescolano la violenza dell’espulsione coatta all’ideazione di masterplan urbani che favoriscono la gentrificazione, dunque l’allontanamento della popolazione palestinese, strutturalmente meno tutelata.
Si arriva, così, a quell’ultima direttrice che è l’obiettivo e il risultato combinato delle prime due: il perseguimento di un “equilibrio demografico” che mantenga la popolazione palestinese, il cui tasso di crescita è più alto di quello della popolazione ebraica, entro livelli numericamente controllati e controllabili, facilmente sfruttabili economicamente senza diventare demograficamente e politicamente preoccupanti. Ghettizzazione ed espulsione sono, perciò, due facce della stessa medaglia: la colonizzazione sionista della Palestina, realizzata attraverso la creazione artificiosa di una maggioranza ebraico-israeliana e di un mercato vincolato di forza lavoro a basso costo, a cui peraltro vendere i prodotti del suo stesso sfruttamento.

Il campo rifugiati di Shu’fat, a Gerusalemme est. Foto di Collettivo Zenobia
Questo è il senso del lavoro di Al-Haq, che la Summer School vuole trasmettere: documentare le diverse forme attraverso cui si riproduce l’occupazione e la colonizzazione per ricostruire, tassello dopo tassello, il disegno di un mosaico che, lungi dall’essere legato all’atto di fondazione (il 1948) o alla fase più notoriamente espansionistica dello Stato di Israele (il 1967), ridescrive il concetto di Nakba come un processo che ha avuto inizio 75 anni fa e che continua, in forme diverse, ininterrotto. Pagine Esteri