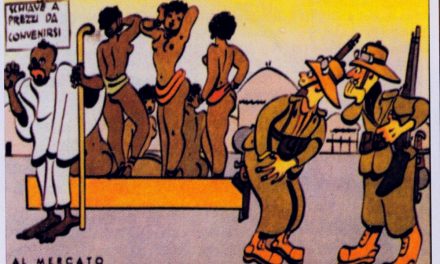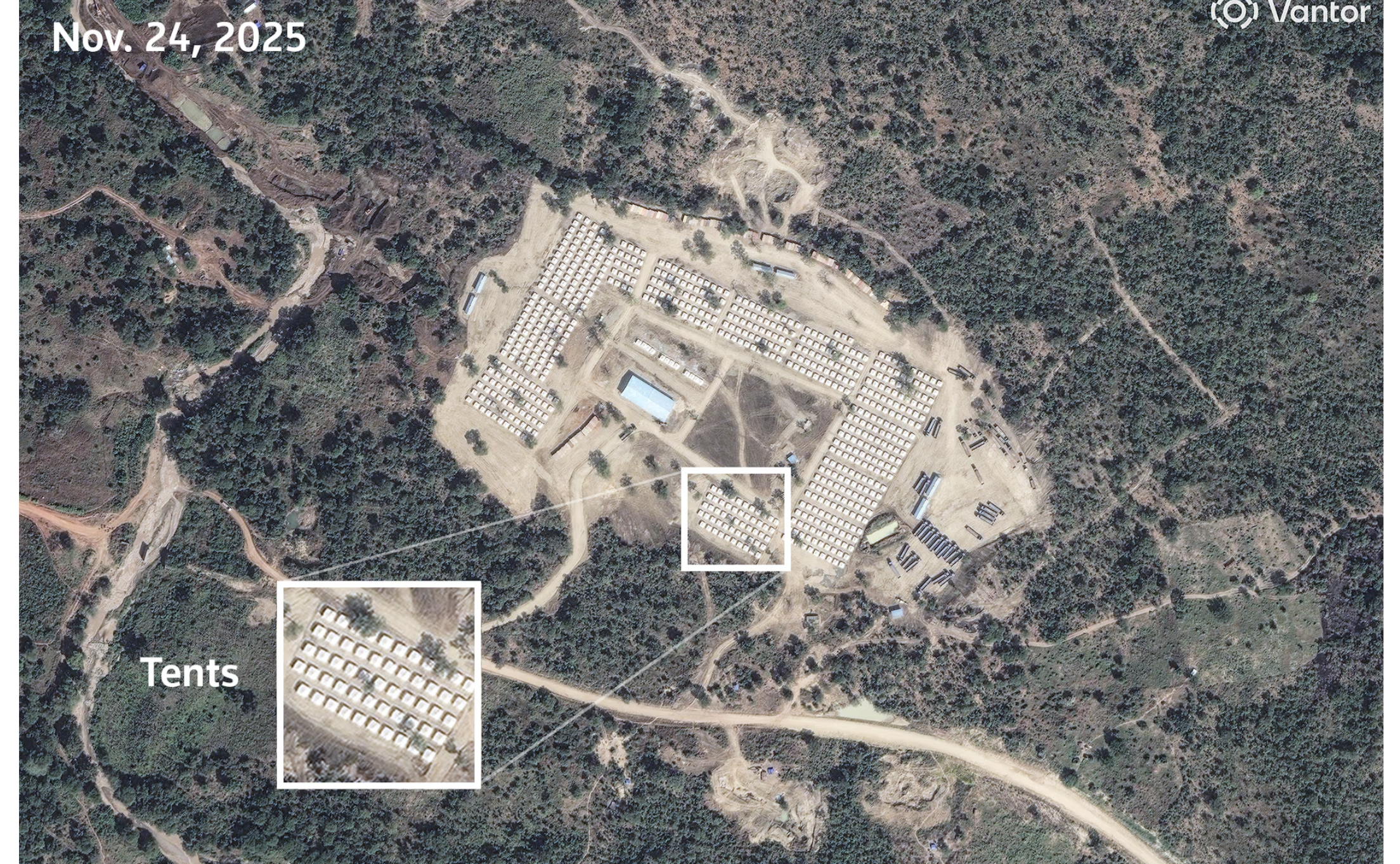di Caterina Maggi
Pagine Esteri, 19 gennaio 2022 – È noto da tempo, anche tramite studi scientifici, che il Medio Oriente sia particolarmente vulnerabile. Dalla scarsità di risorse idriche strutturale, da secoli al centro di contese tra stati limitrofi per il controllo dei corsi d’acqua, all’impoverimento del suolo e al conseguente dissesto idrogeologico, l’area del Medio Oriente mediterraneo in particolare è esposta a cambiamenti sempre più estremi. E come se tutto ciò non bastasse, la presenza di governi inadempienti, o collusi con le monarchie petrolifere (quelle che meno hanno da guadagnare da una transizione ecologica) o con regimi di occupazione rende ancora più difficile per alcuni popoli, sottoposti a pesanti pressioni esterne, riuscire ad organizzare un’efficace risposta al disastro climatico. Una di queste zone a rischio, è Gaza.
Gaza è l’emblema di quanto disperata sia la resistenza climatica. Il problema principale è l’acqua: quella che manca o, come le ultime settimane, quella di troppo. Già nel 2008 uno studio di Jeannie Sowers, Avner Vengosh e Erika Wheintal, pubblicato su Science Spring, mostrava come tra tutte le zone limitrofe la striscia di Gaza risentisse in modo particolare della scarsità di precipitazioni: appena 320 metri cubi pro capite l’anno, in un territorio dove una cattiva amministrazione e la costante minaccia israeliana rendono difficile l’approvvigionamento per via non pluviale. Inoltre, la crescita della popolazione, a un tasso annuo del 2,25% che ha portato il conto approssimativo degli abitanti a 1,85 milioni, richiede cibo, prodotto in loco visto che gli scambi con l’esterno sono praticamente azzerati. Questo produce ulteriore disparità idrica, visto che parte dell’acqua va devoluta all’agricoltura di sussistenza.
E non solo: dell’acqua presente nel terreno della Striscia, nelle falde acquifere, larga parte è imbevibile, e la presenza di pozzi abusivi non controllati dall’amministrazione palestinese – almeno 3000 nel 2000 – rende difficile impedire alla popolazione di utilizzare acque contaminate (che d’altra parte sono l’unica risorsa possibile). Solo il 3 % dell’acqua presente nelle falde acquifere della zona è potabile, con un patrimonio di H2O pro capite di 21 litri (contro i 100 raccomandati dalle Nazioni Unite); nella vicina Israele è di 280 litri per persona. Il resto è inquinato dalla commistione con le acque reflue o contaminate (niente di cui stupirsi in un luogo dove far sopravvivere un impianto di depurazione ai bombardamenti è un’impresa titanica) o ancora dalla penetrazione dell’acqua salina del mediterraneo, visto che il livello del mare sta salendo a un ritmo preoccupante minacciando proprio quel 31% di territorio coltivabile. Ma anche i bombardamenti sono un problema: ordini in attesa di essere disinnescati e altri apparati bellici inesplosi, con le piogge, rischiano di rilasciare sostanze pericolose che inquinano le falde acquifere attraverso il terreno.

Gaza. Foto di Michele Giorgio
L’acqua è in generale un problema anche quando è troppa, per esempio a causa di eventi meteorologici straordinari. Dopo essere già finita sott’acqua nel 2014, la città di Rafah è di nuovo vittima di un’alluvione. Il 16 gennaio scorso piogge torrenziali, insolite per il periodo, hanno riversato sulle sue strade almeno 3 volte il livello di precipitazioni medio della stagione. Sono 152 le persone che hanno avuto bisogno di soccorso, portato utilizzando le barche per la pesca come gommoni di salvataggio; le immagini mostrano fiumi in piena trascinare via dalle strade macchine, bidoni dell’immondizia, terreno. E l’acqua fangosa e sporca di tutto ciò che l’ha contaminata per le strade potrebbe riversarsi nelle falde acquifere, peggiorando la situazione di inquinamento.
Acqua, smaltimento dei rifiuti, inquinamento dell’aria dovuto alle esplosioni e alla combustione di sostanze pericolose: Gaza è sotto assedio da ogni lato, non solo da parte dell’Uomo ma anche da parte degli effetti catastrofici che il suo comportamento scellerato produce sull’ambiente. Iniziative dei singoli, come la guest house di Gaza City costruita a partire da materiali riciclati e di recupero, non possono nulla se le amministrazioni e le forze di occupazione non operano per salvaguardare ambiente e popolazione. In generale, la COP26 avrebbe dovuto stabilire (o meglio ribadire) un principio fondamentale del diritto internazionale: chi si dedica a un’operazione di occupazione militare, è responsabile della popolazione civile sotto il suo controllo. Anche per quanto riguarda la sicurezza climatica.
Naftali Bennet nella città scozzese aveva assicurato che “il paese delle start up” avrebbe implementato i suoi sforzi nel “blue new deal”, il progetto israeliano che coniuga energia fotovoltaica e desalinizzazione dell’acqua. Ma come hanno anche sottolineato le associazioni ambientaliste, sia palestinesi che israeliane, basterebbe arrestare lo sfruttamento indiscriminato dei corsi d’acqua – tra cui il vitale fiume Giordano – e mettere un freno alla deforestazione e alla distruzione delle coltivazioni di ulivo, non solo patrimonio immateriale del Mondo e della Palestina, ma anche ultima trincea contro il dissesto idrogeologico di un territorio fragile. Il piano di Israele per la gestione del cambiamento climatico è più propaganda che pratica. Per il resto, fa (letteralmente) acqua da tutte le parti.