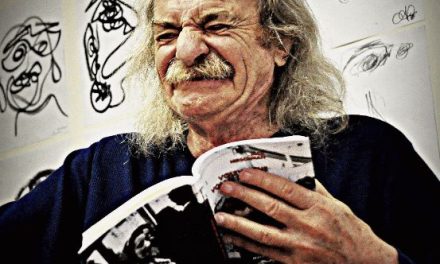di Miriam Zenobio*
(le foto di Jenin dopo l’ultima operazione militare israeliana sono di Michele Giorgio)
Pagine Esteri, 10 luglio 2023 – La domanda che riecheggia in molti titoli di giornale è se Israele abbia raggiunto i suoi obiettivi a Jenin, segnando quella che viene già definita come la più significativa operazione militare israeliana nel campo profughi della Cisgiordania settentrionale dopo la famigerata operazione Scudo difensivo del 2002. Tuttavia, in mezzo a queste discussioni, ciò che rimane inesplorato è la vera natura di questi obiettivi. Mentre alcuni non prendono nemmeno in considerazione la legalità o legittimità di questa operazione proclamata come azione di antiterrorismo, gli osservatori più accorti sottolineano giustamente che tali sforzi alimentano la resistenza armata palestinese invece di sradicarla. A più di settant’anni dalla Nakba e in più di mezzo secolo di occupazione, sembra che i presunti obiettivi “antiterroristici” di Israele continuino a non essere raggiunti. In sostanza, nonostante le fluttuazioni, la resistenza armata palestinese continua a riemergere. Persino gli Stati Uniti, dopo aver tratto insegnamenti dalla guerra urbana contro-insurrezionale di Israele, alla fine hanno riconosciuto la loro inadeguatezza nel sedare la resistenza in Iraq e in Afghanistan. Di conseguenza, il generale Petraeus si è rivolto alla Pacificazione dell’Algeria del generale francese David Galula come quadro di riferimento per integrare le strategie di contro-insurrezione con mezzi di persuasione politica.
In altre parole, la violenza genera violenza, ma Israele non sembra essere preoccupato da questa prospettiva. E questo pone una domanda: chi trae veramente vantaggio dalla continua campagna di Israele tra le guerre? Jenin potrebbe essere la chiave della risposta.

La routinizzazione della guerra e l’integrazione del conflitto armato nella vita quotidiana hanno portato il famoso sociologo israeliano Baruch Kimmerling a descrivere Israele come l’incarnazione del “militarismo totale”. Egli sosteneva che il militarismo civile fosse centrale nella percezione di sé della società e nello sviluppo delle sue dottrine sociali, militari, interne e di politica estera. Kimmerling ha sostenuto che la militarizzazione della società israeliana era così pervasiva che anche istituzioni apparentemente non correlate, come il sistema scolastico e giudiziario, ne mostravano l’influenza diffusa. Analogamente alla sua notevole analisi dello statalismo israeliano come religione di Stato, Kimmerling ha osservato come il militarismo in Israele funzioni come religione civile della sicurezza. Quindi, come qualsiasi altra religione, il militarismo sarebbe adottato da ogni cittadino israeliano in tenera età senza alcuna discussione. A livello istituzionale, ciò si traduce in una sacra enfasi sulle considerazioni militari e strategiche come fattori primari che influenzano il processo decisionale civile, sociale e politico. In sostanza, tutti gli aspetti della società israeliana sono orientati alla preparazione e all’impegno costante nella guerra.
Così come alimenta l’autoidentificazione collettiva e guida tutti gli aspetti della vita in modo evidente, il militarismo israeliano ha una portata anche sulla sfera economica?
Il miracolo economico di Israele, nonostante le sue continue guerre, è stato ampiamente discusso. Tuttavia, è plausibile che queste guerre non abbiano ostacolato il suo successo, ma piuttosto vi abbiano contribuito. I critici sostengono da tempo che l’occupazione di Israele ha avuto un impatto negativo sull’economia del Paese, con costi significativi. Essi affermano che l’enfasi del Paese sul militarismo ha portato a continui investimenti nell’espansione delle infrastrutture degli insediamenti, spesso a spese degli svantaggiati all’interno di Israele. Tuttavia, un esame più attento rivela che l’approccio militarista di Israele è stato la forza trainante della crescita, della prosperità e persino dell’ingegno del suo settore economico più importante, facendogli guadagnare la stimata reputazione di “start-up nation”. Mi riferisco in particolare al settore tecnologico e all’industria militare, che, come ha commentato Yotam Feldman, “non appartiene a pochi venditori, ma è di proprietà dell’intero Paese”.

Nel suo stimolante documentario “The Lab” (2013), Feldman mostra efficacemente le connessioni tra l’operazione Scudo difensivo (2002) a Jenin e lo sviluppo di importanti prodotti di punta della fiorente industria israeliana del commercio di armi, come il CornerShot brevettato dal tenente colonnello Amos Golan. In effetti, le esportazioni di armi di Israele hanno subito un’impennata senza precedenti nel 2002, sfruttando il clima post 11 settembre. Il valore di queste esportazioni è salito alle stelle, più che raddoppiando rispetto all’anno precedente e culminando in uno sbalorditivo record di oltre 4 miliardi di dollari. Sorprendentemente, due decenni dopo, questa cifra è salita a ben 12 miliardi di dollari. In particolare, i Paesi firmatari degli Accordi di Abramo contribuiscono per il 24% a questa somma, mentre i Paesi europei rappresentano il 29% della composizione delle esportazioni, al secondo posto dopo i Paesi asiatici.
Perché c’è una domanda così alta di armi israeliane? La risposta potrebbe inizialmente apparire ovvia: Israele si è affermato come produttore leader e innovativo di armi, guadagnandosi il plauso per le sue avanzate capacità tecnologiche che consentono di massimizzare gli obiettivi militari con un bassissimo costo di vita (militare, non civile) in quella che viene ormai condotta come una guerra sempre più remota. In una candida conversazione con Feldman, Binyamin Ben-Eliezer, ex generale, ministro dell’Industria, delle Infrastrutture e della Difesa a più riprese, ha risposto con sicurezza che la gente gravita naturalmente verso prodotti che sono stati rigorosamente testati. Molte compagnie dell’industria militare israeliana affermano con orgoglio che le loro creazioni sono state sottoposte a test approfonditi per diversi decenni, vantando fiducia nella loro qualità e affidabilità.
Pertanto, l’industria militare israeliana considera l’occupazione della Palestina come un fertile terreno di prova. Naomi Klein ha osservato come, grazie all’occupazione, Israele sia diventato “uno showroom aperto ventiquattro ore su ventiquattro, un esempio vivente di come si possa godere di una relativa sicurezza in mezzo a una guerra costante”. Con orgoglio, gli sviluppatori di armi israeliani, molti dei quali sono veterani dell’esercito, affermano che la Cisgiordania e la Striscia di Gaza agiscono come laboratori reali, consentendo loro di sperimentare nuove tecnologie e armi direttamente sul campo.
D’altronde, perché limitarsi a impiegare un ambiente di simulazione, con ritagli di cartone in finti villaggi palestinesi, quando si possono apprendere le più avanzate tecniche di guerra urbana, come il “mouse-holing”, le manovre dei bulldozer blindati e i nidi di trappole esplosive, proprio nel mezzo di un vero
villaggio con veri palestinesi? E’ questo il caso delle esercitazioni militari svolte a Masafer Yatta, aka Zona di tiro 918, nelle colline a sud di Hebron, dove un migliaio di persone oltre a vivere sotto continua minaccia di espulsione, vedono i loro villaggi trasformarsi in qualcosa di simile al set cinematografico di Fauda – se non fosse che le ferite sono vere.
In questo complesso scenario, l’importanza di Jenin non può essere sottovalutata. È stato, infatti, proprio, nell’aprile 2002 che l’IDF ha effettuato una svolta strategica, scatenando una forza devastante che l’ha distinta dai precedenti sforzi militari israeliani in Cisgiordania. Stephen Graham racconta questo momento cruciale, sottolineando l’impareggiabile potenza dimostrata dall’IDF a Jenin, e in misura minore in altre città della Cisgiordania, con un numero impressionante di morti e sfollati, a fronte di pochissime perdite israeliane. Inoltre, Michael Evans sostiene che l’operazione Scudo difensivo a Jenin non solo ha segnato un punto di svolta nella strategia di guerra urbana di Israele, ma è anche servita come esempio paradigmatico di una nuova forma di guerra asimmetrica. L’operazione Defensive Shield ha mostrato l’evoluzione delle strategie successivamente impiegate da altri eserciti statali tecnologicamente avanzati quando si sono confrontati con gruppi di insorti, a scapito delle ingenti perdite civili che si sono verificate nei teatri urbani densamente popolati dove hanno avuto luogo.

Inutile dire che gli Stati Uniti sono stati i primi a adottare le tattiche pionieristiche di contro-insurrezione urbana potenziate dai sofisticati armamenti israeliani e dalle loro tecnologie avanguardistiche – come dimostrano i casi documentati di soldati americani, vestiti con l’equipaggiamento dell’IDF, che hanno diligentemente osservato e assimilato le lezioni dello sfollamento e demolizione del campo profughi di Jenin nel 2002. Tuttavia, le forze armate americane non sono state le sole a riconoscere il valore dell’incorporazione di metodi israeliani e di armi avanzate nelle loro strategie antiterroristiche, che hanno poi impiegato in Iraq e Afghanistan. Attirando l’attenzione a livello globale, gli ufficiali militari di varie nazioni convergono ogni anno in Israele per partecipare alle simulazioni militari organizzate dai principali produttori di armi del Paese. Tra i principali beneficiari, il Brasile ha dimostrato una notevole scrupolosità, tanto che uno dei quartieri più afflitti dalla Guerra alla droga a Salvador, noto come Baixa dos Sapateiros, si è guadagnato il soprannome di Striscia di Gaza bahiana.
Il rapporto dell’Europa con il settore degli armamenti di Israele, come ha osservato Antony Loewenstein nel suo ultimo libro “The Palestine Laboratory”, non è da meno e Horizon ha giocato un ruolo cruciale nello scambio. Il generale israeliano Yoav Gallant ha criticato l’ipocrisia dell’Europa. Da un lato, l’Europa critica le azioni politiche di Israele, ma dall’altro, ammira con convinzione la capacità di Israele di infliggere danni significativi con perdite minime. È interessante notare che, secondo alcuni rapporti, la presidenza francese avrebbe chiesto consiglio alle autorità israeliane durante gli ultimi violenti disordini popolari in Francia.
Tutto ciò suggerisce che Israele non dipende solo ontologicamente dall’occupazione dei palestinesi, ma anche economicamente. L’occupazione della Palestina funge da incubatrice di idee per la risoluzione dei problemi che vengono tradotte in modo fruttuoso nell’industria delle armi ed esportate in tutto il mondo accrescendo il suo status a livello internazionale. Come nel 2002, anche oggi, ciò che resta da vedere da quest’ultima operazione a Jenin non è se abbia raggiunto gli obiettivi antiterrorismo di Israele, ma piuttosto cosa prospetta per la guerra futura. Pagine Esteri
*Ricercatrice in Middle Eastern Studies e International Security Studies. Ha vissuto e studiato in Israele-Palestina e ha esperienze lavorative presso le Nazioni Unite e l’Istituto Affari Internazionali.