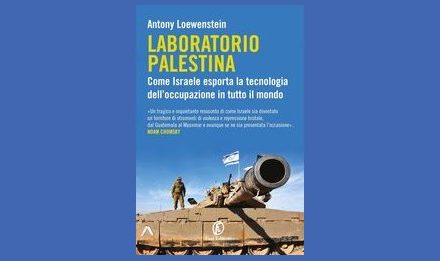Bloccati a Gaza ci sono sette cittadini israeliani che chiedono da due mesi il permesso di rientrare. Ma Tel Aviv non risponde ai loro appelli: nessun aereo si è alzato in volo, i droni non hanno bombardato né le squadre speciali sono state inviate sotto copertura per recuperarli. Rimpallandosi responsabilità e doveri, le autorità israeliane li hanno anzi abbandonati al proprio destino. Anche questo significa la parola “apartheid”, che le Nazioni Unite sono recentemente tornate a pronunciare descrivendo la situazione dei palestinesi nei Territori occupati. Ma l’amministrazione discriminatoria dispiega i suoi artigli anche all’interno dei confini di Israele, uno stato in cui il 20% circa dei suoi cittadini è di origine araba palestinese.
Sono per la maggior parte i discendenti delle famiglie che vivevano in quelle aree della Palestina storica dichiarate unilateralmente “Israele” nel 1948 e di quelle occupate nel 1967. Dentro quei confini, dopo le ondate migratorie e poco prima della nascita dello Stato ebraico e della conseguente pulizia etnica definita Nakba, la popolazione araba e quella ebraica si equivalevano in numeri. Dopo lo sfollamento forzato dei palestinesi da parte delle bande e delle milizie armate sioniste e la negazione del diritto al ritorno dei profughi, gli abitanti secolari della Palestina storica sono diventati una minoranza nel neonato stato israeliano. Discriminata da decine di leggi, partendo da quella cosiddetta “fondamentale” che definisce l’esclusività etnica dello stato: “Il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è unico per il popolo ebraico”.
Tra le altre, una norma confermata dall’Alta Corte di Giustizia israeliana nel 2012 vieta i ricongiungimenti familiari per le famiglie formate da coppie con due diverse cittadinanze: una israeliana (di solito per la donna) e l’altra dei Territori palestinesi occupati. Il coniuge che non ha cittadinanza israeliana può chiedere dei permessi di soggiorno, che sono rilasciati spesso a discrezione dei dipendenti del Ministero degli Interni e che hanno limiti di durata stringenti. Una settimana ogni tre mesi all’inizio, per visitare moglie/marito e figli. Poi una al mese. Per chi vive a Gerusalemme est, ossia nella parte araba della città, che Israele tiene sotto occupazione, la situazione è ancora più complessa. Qui, anche se un genitore ha cittadinanza israeliana, i propri figli non la assumono direttamente e dopo il compimento dei 14 anni di età sono costretti a chiedere permessi militari per rimanere nella città in cui sono nati e dove da sempre hanno vissuto.
La storia degli impossibili ricongiungimenti è anche quella dei sette cittadini israeliani che provano ad uscire da Gaza. Sono arabi palestinesi che vivono in aree diverse di Israele. Uno di loro proviene da Gerusalemme est ma ha comunque cittadinanza israeliana. Sappiamo che si tratta di sei donne e un uomo. Che il più giovane di loro ha quattro anni e il più anziano è un 67enne. Sono entrati a Gaza prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e quindi della chiusura totale della Striscia da parte di Israele. Con l’inizio dei bombardamenti sono rimasti bloccati al suo interno.
Sono 450 i cittadini israeliani che possono richiedere permessi – solo temporanei – di ricongiungimento familiare per entrare a Gaza. Chi il 7 ottobre si trovava fuori dalla Striscia non ha più potuto richiederne l’ingresso e quindi visitare coniugi, genitori e parenti. Tra novembre 2023 e agosto 2025 Tel Aviv ha permesso l’uscita da Gaza a 152 cittadini israeliani, in coordinamento con le organizzazioni umanitarie Gisha e HaMoked. Il ruolo delle due Ong è stato e continua ad essere fondamentale per superare la valanga di impedimenti e ritardi burocratici con cui lo stato di Israele gestisce le richieste di rimpatrio presentate dai suoi cittadini arabi palestinesi. Inoltre, a differenza di molti altri Paesi che hanno lavorato per garantire il rimpatrio dei propri cittadini, Tel Aviv vieta l’accompagnamento in Israele da parte di figli, coniugi e genitori, pure per quelle persone che necessiterebbero assistenza. È questo uno dei motivi per cui molti palestinesi con cittadinanza israeliana, soprattutto donne, hanno ritardato la richiesta di rimpatrio: non avrebbero potuto abbandonare a Gaza, sotto bombe e in crisi umanitaria, genitori anziani, parenti disabili, familiari malati e feriti.
Il gruppo dei sette palestinesi con cittadinanza israeliana (non si sa se siano uniti da legami o parentela) ha quindi presentato richiesta urgente subito dopo il cessate il fuoco, cominciato il 10 ottobre 2025. Tra di loro c’è una donna che necessita di cure non disponibili a Gaza, mentre gli altri adulti hanno necessità di lavorare per aiutare economicamente i parenti rimasti nella Striscia. Ma le autorità israeliane non si muovono. L’associazione Geisha sta gestendo le richieste, che vengono però sistematicamente respinte o ignorate dalle autorità israeliane. Il Cogat, l’agenzia che coordina le attività governative nei territori occupati, ha dichiarato al giornale israeliano Haaretz che la competenza sarebbe dell’Autorità per la popolazione e l’immigrazione. Quest’ultima ha invece risposto ai giornalisti che spetta all’autorità militare identificare i cittadini e coordinare il loro ingresso nel Paese.
L’avvocato Osnat Cohen-Lifshitz, capo del dipartimento legale di Gisha, ha definito “crudele” la condotta delle autorità statali, che rappresenta a suo parere una violazione dei diritti fondamentali. “Ogni cittadino ha il diritto di tornare nel proprio paese di cittadinanza”, ha dichiarato il legale. Una frase solo in apparenza semplice, che in uno Stato come Israele si carica del peso di una lunga storia di espulsioni, di negazione del diritto al ritorno e di discriminazione etnica.