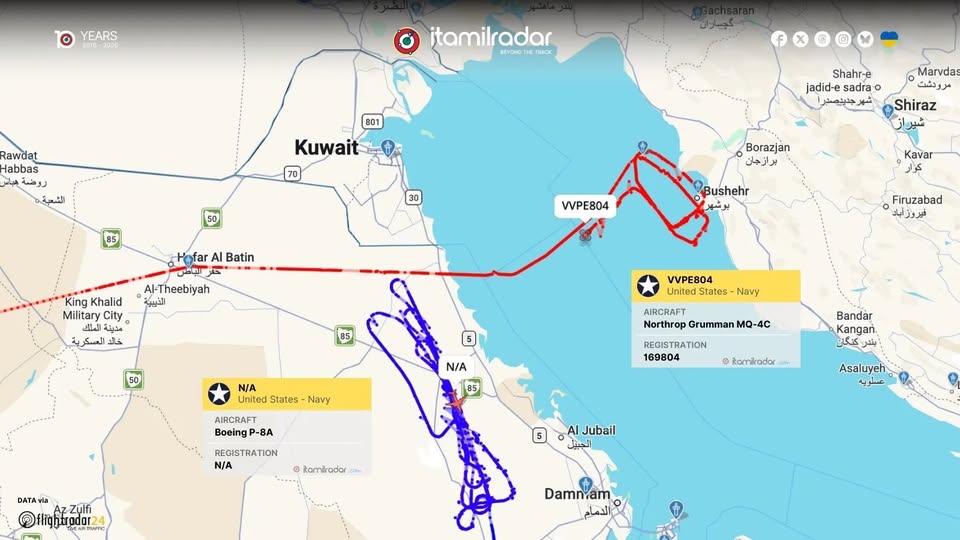di Pietro Figuera*
Pagine Esteri, 15 luglio 2021 – Non è propriamente una notizia, dato che si tratta di un’evidenza ormai visibile a chiunque. Ma con l’ufficialità del ritiro statunitense dall’Afghanistan lo si può affermare ormai apertamente: la “tomba degli imperi” ha colpito ancora. Il Paese centroasiatico si è infatti confermato per l’ennesima volta come un obiettivo irraggiungibile per qualsiasi potenza, persino per le più grandi di ogni epoca: l’impero britannico dalla metà dell’Ottocento e per i decenni successivi; l’Unione Sovietica per l’intero corso degli anni Ottanta del Novecento; gli Stati Uniti per questi venti anni quasi compiuti della loro missione contro il terrorismo.
A voler andare più lontano, si scopre poi che i territori dell’attuale Afghanistan sono stati una sorta di buco nero anche in epoche per noi arcaiche, come quella in cui il macedone Alessandro Magno venne quasi risucchiato dagli impervi sentieri tra la Battria e l’Aracosia. Forse si tratta solo di coincidenze, e più che di una presunta maledizione afghana si dovrebbe parlare di overstretching di imperi che hanno osato troppo. Ma in ogni caso, l’esperienza di chi ha provato ad aver ragione dei locali resta come un monito per ogni futuro tentativo di controllo, e da qualsiasi parte esso provenga.
Con queste premesse, è difficile che qualcuno riesca (anzi, anche solo “voglia”) a sostituire Washington nel presidio della “repubblica” centroasiatica. Le virgolette sono d’obbligo, perché l’Afghanistan oggi quasi non esiste più come entità politica: il governo non ha i mezzi per contrastare le offensive dei taliban, che già prima dell’abbandono americano dettavano legge in ampie porzioni di Paese. Adesso il presidente Ghani e i suoi (pochi) fedeli possono dichiarare sotto controllo ben pochi territori, oltre alla capitale. E pure a Kabul il caos si avvicina ad ampie falcate: qualche settimana fa, una commissione di esperti d’intelligence ripresa dal Wall Street Journal ha previsto il collasso finale dell’attuale governo entro sei mesi dal completamento del ritiro statunitense.

Se gli americani gettano la spugna, a venti anni quasi suonati da quell’11 settembre che li lanciò in una missione intrinsecamente impossibile, nessun altro forse potrà realmente venire in soccorso di chi ancora resiste all’avanzata talebana. Nemmeno quella Turchia che oggi sembra volersi prendere la responsabilità della copertura militare di una transizione rapida (ma niente affatto indolore): Ankara – questi gli accordi presi con Washington – proteggerà l’aeroporto internazionale di Kabul e alcuni punti nevralgici del Paese. Ma una simile posizione, presa anche per ragioni di prestigio, ha il suo prezzo da pagare: la “fatwa” dei taliban è stata immediata, a dimostrazione che nessuna (presunta, tra l’altro) affinità ideologica o culturale “islamista” può attenuare la realtà di un’occupazione militare ventennale.
È il fallimento della NATO, certo, ma neanche i suoi avversari regionali possono sorridere. Non può farlo la Cina: nonostante la sua storica vicinanza al Pakistan, teme i talebani per il loro legame con gli uiguri del vicino Xinjiang. Il movimento fondato dal mullah Omar oggi sembra tendere una mano a Pechino, per pragmatismo (serviranno finanziamenti per la ricostruzione del Paese) e per rompere l’isolamento internazionale, ma la Repubblica Popolare ha fissato alcuni paletti per un regime afghano “ampio e inclusivo”, nonché disposto a rompere coi terroristi e con “l’estremismo islamico”. Il messaggio anti-uiguri è chiaro.
Non può sorridere nemmeno la Russia. È passato meno di un anno dall’accusa – poi dimostratasi infondata – di aver pagato i taliban per uccidere soldati statunitensi. Cosa tra l’altro realmente avvenuta, a parti invertite e in proporzioni ben più massicce, ai tempi dell’occupazione sovietica. Ma di fatto, il vuoto di potere incombente preoccupa Mosca, anche se non confina più direttamente con l’Afghanistan.
Per il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov la soluzione ideale per uscire dalla crisi sarebbe quella di un governo di transizione mediato da un quartetto di potenze: Usa, Russia, Cina e Pakistan. Uno scenario tra quelli messi sul tavolo da Washington, ma rifiutato dal presidente afghano Ghani. E comunque di difficile applicazione, data la difformità degli interessi in campo: il progetto rischierebbe di somigliare al pressoché fallito Quartetto per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, che di fatto oggi in pochi ricordano.
Il Cremlino ha poi un rapporto contraddittorio coi taliban. Non è il solo, certo, ma l’inserimento nella sua lista delle organizzazioni terroristiche (avvenuto nel 2003) cozza con il dialogo avviato col movimento negli ultimi due anni: il “pragmatismo” usato tante volte per mediare in Medio Oriente (persino in Siria) mal si abbina a un’organizzazione che ha finanziato direttamente i ribelli ceceni, quando Mosca e Washington a inizio secolo combattevano parallelamente la “stessa” guerra al terrore.
Ad ogni modo gli ultimi colloqui tra le due parti, avvenuti a Mosca la settimana scorsa, mostrano che una certa volontà di apertura è reciproca: i taliban sarebbero pronti a prendere “tutte le misure affinché lo Stato Islamico non operi nel territorio afghano” (una preoccupazione primaria per i russi, che sul punto insistono molto più degli occidentali), e soprattutto avrebbero garantito di non voler oltrepassare i confini del proprio Paese. Una rassicurazione di una certa importanza, in una fase in cui la loro permeabilità è sensibilmente cresciuta.
A separare la Russia dall’Afghanistan sono gli –stan ex sovietici, oggi in forte agitazione per ciò che si sta verificando nell’area. In prima linea Dusanbe: dei 1400 km di confine tra Afghanistan e Tagikistan, il 70% è già sotto controllo talebano. E migliaia di soldati regolari afghani hanno già varcato la frontiera per salvare la propria vita dall’avanzata dei ribelli. Come se non bastasse, gli Usa di Biden hanno chiesto a Kazakistan, Uzbekistan e allo stesso Tagikistan di trovare una “sistemazione” per almeno 9000 afghani precedentemente occupati in mansioni militari.
Non stupisce dunque che dinnanzi a simili pressioni Dusanbe abbia chiesto l’intervento della CSTO, l’organizzazione di sicurezza collettiva di derivazione post sovietica che di fatto fa capo alla Russia. Il crescente ingresso di afghani attraverso il confine equivarrebbe a una minaccia militare diretta, valida – secondo il presidente tagico Rahmon, da sempre in guerra contro la “radicalizzazione” – ad attivare la solidarietà tra i membri.

Le frontiere interessate sono impervie e difficilmente controllabili nella loro interezza. Ma di certo non fuori dai radar dei russi, che in Tagikistan mantengono una delle loro più importanti basi militari all’estero, la “201” che già in passato è stata utile a pattugliare il confine afghano e a intervenire nella guerra civile tagica degli anni Novanta. Come in altre regioni di sua influenza, la Russia è interessata ad avere pretesti per mantenere una presenza militare. Tanto più adesso che gli equilibri sono in ridefinizione: lo scorso 2 luglio Zamir Kabulov, inviato speciale russo per l’Afghanistan, ha espressamente invitato gli Stati Uniti a non trasformare la loro uscita di scena da Kabul in una scusa per ricollocarsi in altri Paesi dell’Asia centrale. Dove già si affollano gli interessi e le potenze.
Per Mosca, in mezzo a tante preoccupazioni, si configura anche un’opportunità. Al di là del multipolarismo di facciata à la SCO [1], non vi è dubbio che la richiesta di aiuto tagica può essere propizia per ritardare l’avanzata cinese nell’area. Pechino, ovviamente esclusa dal CSTO e relativi meccanismi, starà per il momento a guardare. Possiede leve diverse e le userà a tempo debito. Ma l’emergenza securitaria richiede strumenti che solo la Russia è in grado di offrire. A trent’anni dal “consensuale” divorzio, Mosca e le repubbliche centroasiatiche hanno ancora molto da scambiare.
[1] La Shanghai Cooperation Organization, di cui Cina e Russia fanno parte (e l’Afghanistan è osservatore). Non vi è tra i suoi membri una visione realmente comune sul futuro di Kabul, ma possono ravvisarsi degli interessi di fondo: nessuno vuole vedervi installato un “emirato islamico” né un’organizzazione che possa farvi base per piani terroristici internazionali. Sulla questione afghana dal 2005 è attivo in seno all’SCO un gruppo di contatto teso a favorire un approccio multilaterale, nonostante la rivalità e gli interessi contrastanti – tra gli altri – di India e Pakistan.
 *Laureato in Relazioni Internazionali presso l’Alma Mater di Bologna e in seguito borsista di ricerca con l’Istituto di Studi Politici S.Pio V, si è specializzato in storia e politica estera russa, con particolare riferimento all’area mediorientale. Autore de “La Russia nel Mediterraneo: Ambizioni, Limiti, Opportunità”, collabora con diverse realtà, tra cui la rivista Limes, il Groupe d’études géopolitiques e il programma di Rai Storia Passato e Presente. Ha fondato e dirige Osservatorio Russia, progetto di approfondimento sulla geopolitica dello spazio post sovietico.
*Laureato in Relazioni Internazionali presso l’Alma Mater di Bologna e in seguito borsista di ricerca con l’Istituto di Studi Politici S.Pio V, si è specializzato in storia e politica estera russa, con particolare riferimento all’area mediorientale. Autore de “La Russia nel Mediterraneo: Ambizioni, Limiti, Opportunità”, collabora con diverse realtà, tra cui la rivista Limes, il Groupe d’études géopolitiques e il programma di Rai Storia Passato e Presente. Ha fondato e dirige Osservatorio Russia, progetto di approfondimento sulla geopolitica dello spazio post sovietico.