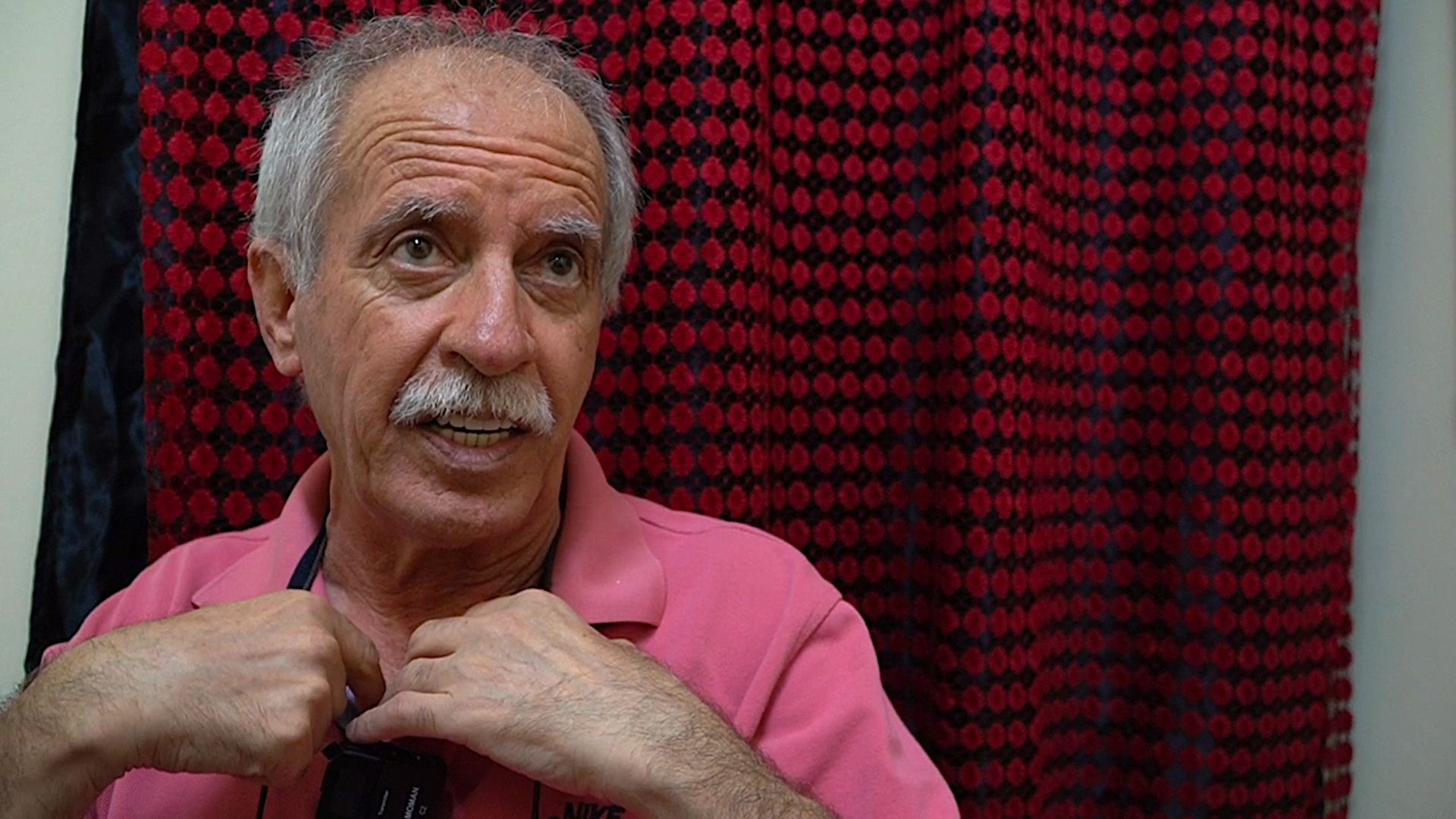di Valeria Cagnazzo
Pagine Esteri, 18 marzo 2022 – “TUTTO QUESTO, ASCOLTALO” – Non solo l’eco delle esplosioni e dello schianto a terra di piani e piani di grattacieli a Gaza, ma anche il lamento degli Armeni in fuga; non solo il cigolio dei tornelli ai checkpoint in Cisgiordania, ma anche il suono delle acque dei fiumi in Iraq. Se leggere poesia è mettersi in ascolto dell’umano in una lingua inimitabile, posando l’orecchio sul libro di Najwan Darwish si sentirà acuto l’urlo di un’umanità disintegrata e oppressa, la sua Babele di pianti levarsi come un canto solo. Darwish non dà tregua, pungola, esaspera, corrode: con voce delicata e matura, ma anche ironica, obbliga a guardare dritto alla verità, ovunque essa sia celata. Senza pietismi, senza fronzoli, come attraverso uno specchio d’acqua trasparente. Il suo verso, e la sua incessante attenzione alla realtà e al dolore umano, riportano alla mente quello che scrisse uno dei più grandi poeti italiani degli ultimi decenni, Mario Benedetti, scomparso nel 2020: “E io dico: accorgetevi, non abbiate solo vent’anni”. Questa raccolta è un invito ad “accorgersi”.
Pubblicato in Italia nel dicembre 2021 per l’editore “Il ponte del sale”, “Più nulla da perdere” è il primo libro tradotto in italiano del poeta palestinese Najwan Darwish. Pubblicata in inglese nel 2014 negli Stati Uniti col titolo “Nothing More to Lose” e candidata nel 2015 al Best Translated Book Award, la raccolta è stata già tradotta in diverse lingue e sta raccogliendo riconoscimenti in tutto il mondo. Diviso in sette sezioni, in cui la poesia in prosa si alterna alla poesia in versi, “Più nulla da perdere” rappresenta un importante momento di cambiamento nella tradizione della poesia araba contemporanea. Il suo autore, Najwan Darwish, nato a Gerusalemme nel 1978, è considerato una delle voci più eminenti del panorama poetico arabo moderno e sta adesso conquistando gli editori e i lettori internazionali.
La prefazione è a cura di Franca Mancinelli, tra le migliori firme della poesia italiana contemporanea, autrice di quattro libri di poesia, da “Mala kruna” (Manni editore, 2007) a “Tutti gli occhi che ho aperto” (Marcos y Marcos editore, 2020). La traduzione dall’arabo è di Simone Sibilio, professore di lingua e letteratura araba all’Università Ca Foscari di Venezia, traduttore e poeta: la familiarità di Sibilio con la poesia si sente ed è necessaria a rendere la poesia di Darwish preziosa anche nella sua versione in italiano. Come ha osservato lo stesso Darwish in un’intervista: “La poesia stessa è una forma di traduzione. Comincia da un livello emozionale, visivo, uditivo, e poi la si trasforma in linguaggio. Questa trasformazione è una traduzione. E quando il traduttore traduce la poesia, compie una trasformazione simile. Qui stanno la bravura e il dono del traduttore, perché il traduttore è anch’egli un poeta. E più bravo è, migliore è la versione della tua poesia che riesce a creare. Con i miei traduttori, io credo di essere stato finora molto fortunato.”

UNA QUESTIONE DI IDENTITA’ – Aprire una raccolta di poesie con “Carta d’identità”, ed essere un poeta palestinese che di Mahmud Darwish porta il cognome (senza esserci legato da qualche parentela), è un atto di coraggio e di responsabilità. Inevitabilmente il titolo riporta, infatti, alla celebre poesia omonima di Mahmud Darwish, considerato il più grande poeta palestinese, alla sua carta d’identità numero cinquantamila, ai suoi quasi nove figli e a quel martellante “Ana arabi” (“Sono arabo”). L’identità che Najwan Darwish definisce a partire dai primi versi, tuttavia, non è più quella del suo predecessore, o quantomeno non è “soltanto quella”. Se per entrambi è importante sottolineare un’appartenenza araba (anche Najwan Darwish recita con durezza “E se si è meno di questo, allora non si è arabi”), è chiaro che Mahmud Darwish si rivolge all’occupante israeliano e che il suo martello recitativo è mirato a demarcare con esattezza il suo essere palestinese. La geografia che Najwan Darwish disegna, invece, rinuncia alle frontiere, si allarga al mondo tutto, e l’essere nato nel posto “più capace di resistere ai suoi invasori” rappresenta solo una cicatrice che gli permetterà di sentire più profondamente il dolore degli altri, e di considerarli suoi fratelli. Najwan Darwish è curdo, egiziano, iracheno: la sua identità conosce solo i codici dell’oppressione e dell’ingiustizia umana. In quanto palestinese, il suo popolo sono gli ultimi della terra, e tutto il libro è un inno alla straordinaria tragedia e bellezza di questo umano sentire.
Il tema dell’appartenenza è il filo conduttore dell’opera, ma ci conduce ben oltre la tradizione della “letteratura della resistenza” che ha fatto la storia della poesia palestinese. Najwan Darwish canta il suo attaccamento alla terra. “Persino in Paradiso, pensavo alla terra”, recita, planando dall’alto su un mondo di tragedie e guerre con una delicata nostalgia di cose umane e terrestri. L’attaccamento all’umano (torniamo a quel dialogo tra umani che è la poesia, ma il lettore di poesie ne è già consapevole, per questo è in ascolto – “Tutto questo, ascoltalo”) è il testamento poetico del giovane Darwish. “In decollo dalla terra / non hai altra via di scampo che l’atterraggio / (…)/ perché sei inchiodato alla terra/ la tua piccola croce”. La croce del dolore degli altri viene portata quasi con orgoglio, come l’unico modo che il poeta conosce di stare al mondo. Persino Gesù non vuole scendere dalla croce in “Mai detto di voler scendere”, vi resta attaccato proprio come il poeta alla terra. Non soltanto al suolo palestinese, come Mahmud Darwish in “Hanno diritto su questa terra”.
“Fare l’amore sotto le bombe. Ricordo di un amico di Nablus che mi spiegava quanto gli fosse difficile ritagliarsi un momento d’intimità con sua moglie durante l’occupazione. Una sera, mentre se ne stavano abbracciati, un proiettile si era conficcato nella testiera del letto, a un palmo dalle loro teste.”. Scriveva così Vittorio Arrigoni, attivista ucciso a Gaza nel 2011, nel suo “Gaza. Restiamo umani” (Il manifesto libri ed, 2011). Quando si sfoglia il libro di Najwan Darwish, si viene calati in un baratro di sentimenti così profondo che quando si arriva al titolo “Dormire a Gaza” ricordare il pezzo di Arrigoni è inevitabile. Anche nella sua poesia, Darwish racconta dell’operazione militare Piombo Fuso. “Dormirò come dormono tutti (…)/ Mi sveglierò solo per chiedere alla radio – come chiedono tutti /hanno smesso di bombardare? A quanto è salito il numero dei morti?”.
E’ proprio in questa poesia scritta nel 2008 che, nello strazio dei bombardamenti sulla Striscia, Darwish svela la sua vera carta d’identità. Qui dichiara apertamente a chi appartiene, qual è il suo popolo, la sua Nazione: “Ma la tragedia, o fado, /è che esistono due categorie di persone:/ quelle che gettano per strada peccati e tormenti per poter dormire / e quelle che raccolgono i peccati e i tormenti degli altri, foggiandone / croci con cui marciare per le strade di Babilonia, Gaza e Beirut/ e poi gridare: / Per quanto ancora?”. Questa è l’identità di Darwish, questa seconda categoria – e quel lettore “in ascolto” vi si riconoscerà commosso. Nel raccontare questa “tragedia” Darwish non è mai “tragico”, è sempre pungente e ironico come chi detiene felicemente una grave responsabilità: “la caduta è forse questo”, scriveva Blanchot ne “L’amitié” a proposito dell’artista, “il non poter più essere un destino personale, ma la sorte di ciascuno in tutti”. A questo destino appartiene Darwish.
L’ATEISMO E LA CROCE – L’allusione al mondo religioso è ricorrente, mai banale e tetra. Darwish dichiara di non credere e lo dimostra con toni spesso dissacranti. La figura di Cristo in croce, tuttavia, e la simbologia liturgica delle tre religioni, diventano espedienti fondamentali per il poeta. Toni profetici e riferimenti biblici si incrociano con il quotidiano e con le esistenze dei poveri cristi dimenticati anche da Dio. La croce è trascinata da chi vuole farsene carico o da chi vi è condannato, in croce vengono messi i Palestinesi e i loro chiodi sono le bombe su Gaza, sulla croce è anche il poeta che come Gesù non vuole abbandonarla. Di stampo cristiano è anche l’immagine del debito e dell’espiazione: la vita è come un debito che si paga nei confronti dei caduti. Cosa fare, dunque? “Offrire se stessi”, recita il poeta in tono evangelico. Liturgico quando parla alla sua città, Gerusalemme: “E a vedere le nostre mani levarsi, vuote/ capimmo di essere noi il tuo sacrificio”. Nel suo “Testamento”, dipinge un clima da orto degli ulivi: “Fate turni nel dimenticare / e rilassatevi”, come se si rivolgesse agli apostoli in veglia.
Potrebbe sembrare scontato, speculare sull’immaginario della croce nella città del Santo Sepolcro, ma Darwish sa sorprendere. Il suo Gesù è quello di Rio de Janeiro, è l’enorme statua del Cristo Redentor, in America Latina, alla quale dire “Avanti, torna con me a Gerusalemme”.
In una poesia a tratti impetuosa, i riferimenti religiosi offrono i momenti più delicati del libro, quelli in cui forse neanche troppo consapevolmente questo poeta ateo si mette veramente a nudo. Qui è ancora una dichiarazione di poetica di Darwish: “Dio, trasformami in liuto (…)/ Ma se non lo merito, Signore, / spaccami adesso!”. Tornano alla mente i versi di Rainer Maria Rilke: “Che farai, Dio, se muoio? Sono la tua brocca (e se mi spacco?)”.
Le anime del Purgatorio, infine, sono “gli espulsi dalle loro terre” – i Palestinesi.

LA PALESTINA E IL MALE TENACE DELLA SPERANZA – La Palestina si introduce in questo libro su più livelli di lettura. Darwish guarda a ogni cosa da umano tra gli umani, è stato detto, ma si tratta pur sempre di un umano che vive in Palestina. Sagace e spietato, rifiuta il registro della compassione e dell’autocompatimento: “Che vadano all’inferno i tuoi adoratori / i mercanti di souvenir del tuo dolore”.
La Palestina è nei luoghi, nella città di Gerusalemme, ad Haifa, nei campi profughi di Sabra Chatila, nella Striscia di Gaza illuminata a giorno dalle bombe, ma c’è anche, soprattutto, quando non viene nominata ma si affollano i temi della fuga, dell’ingiustizia, dell’oppressione, le immagini di case distrutte dai tank, di muri e checkpoint. Alla questione palestinese appartengono gli “eroi” disarmati e sconfitti che vengono evocati, tra i quali spicca anche quella che sembrerebbe essere Rachel Corrie, attivista americana uccisa da un bulldozer israeliano a Gaza nel 2003: “E chi è quella ragazza /ferma davanti alla ruspa /che l’ha spianata come un mandorlo a marzo?”.
La Palestina si introduce nel subconscio e nelle paure del poeta: ricorrono gli incubi a tormentarlo, e tutti sembrano avere una matrice comune nella storia del suo popolo. Si intitola “Fobia” la poesia in cui si logora in preda a ripetuti “Verrò espulso”.
Se è vero che la patria del poeta è il mondo intero, in quest’opera che vorrebbe accogliere l’umanità di tutte le epoche tra le sue pagine, il dramma palestinese è l’elemento che riconduce all’attualità: si parla di coloni, di sionismo, di israeliani, la realtà viene circostanziata con riferimenti esatti di date e di nomi. In una prova straordinaria di poesia in prosa alla fine del libro, sono puntuali i riferimenti ai telegiornali e ai presentatori israeliani, citati coi loro nomi, e alle emittenti Al-Jazeera, Al-Arabyia, Al-Hurra. E’ il primo aprile del 2010, una data esatta. La realtà viene inchiodata al muro proprio nel momento più satirico e critico del libro, in cui Darwish costruisce uno strano gioco intorno al concetto di verità. Nel mondo globalizzato, e i fatti recenti lo stanno di nuovo dimostrando, solo quello che viene raccontato “esiste”. Forse è tutta un’invenzione, suggerisce il poeta con un sorriso acre, la sofferenza del popolo palestinese, alla luce delle versioni mediatiche riguardo a quanto accade in quella terra. Tutto il dolore degli ultimi che viene ignorato dalle trasmissioni televisive in prima serata è probabilmente un’invenzione. Darwish gioca su questo paradigma dell’assurdo fino a dubitare della sua esistenza e che questa un giorno possa finire: l’ipocrisia è disvelata, il vortice di immagini si può interrompere. Su un verso che è un ossimoro geniale: “Crepiamo dal ridere, non moriremo mai”.
La rabbia lo rende corrosivo, fino a non lasciarsi intimorire neppure dall’immagine delle camere a gas. Darwish è spietato, ma la sua è una riflessione che riguarda tutti, e non solo i Palestinesi. La bulimia mediatica della guerra in Ucraina dei nostri giorni sta provocando un turbamento delle masse in Occidente molto diverso rispetto a quello suscitato da guerre ad altre latitudini, dai conflitti in Yemen, in Afghanistan, dalla questione palestinese, che pure hanno “coinvolto” l’Europa, se non altro per i profughi lungo i suoi confini. Il doppio standard nella narrazione – e nella partecipazione “umana” – non può sfuggire al poeta. “Non ho nonne morte nelle camere a gas (…)/ Che orrore fu la Nakba (l’espulsione dei Palestinesi dalle loro terre nel ’48, ndr)? /Quanto è stato duro essere profughi?/ Ma queste sono minime tribolazioni per neri come noi”. Questa è la risposta di Darwish: in quel loro essere “neri” sta il motivo del disinteresse del mondo per le sofferenze di alcuni popoli.
Esiste forse la speranza? Malgrado tutto, sì. Col suo dire brillante in fondo in nessun momento Darwish riesce a mascherare la sua innata vitalità. Quell’attaccamento alla vita che è la sua identità è un moto vivace, allegro, giocoso. E’ consapevole della sua speranza, il poeta, quasi fosse una condanna. “La pena che risplende, ora, mi è più cara degli incubi”, scrive Darwish, che non potrebbe appartenere alla “seconda categoria” umana se non fosse animato da un’utopia. Dolorosa da portare avanti, indubbiamente. “Ho perso ormai la speranza / ma continuerò a cercare e a sbandare / io che non ho mai detto di voler scendere”, dice. “Una parola avvelenata di speranza”, si legge, ancora, e la definizione non può non ricordare i versi del poeta Mahmud Darwish sullo stesso tema: “Resistere significa: accertarsi della forza/ del cuore e dei testicoli, e del tuo male tenace:/ il male della speranza”.
Un poeta da scoprire e un libro da leggere, destinato all’umanità che vuole mettersi “in ascolto”, che è pronta ad “accorgersi”.