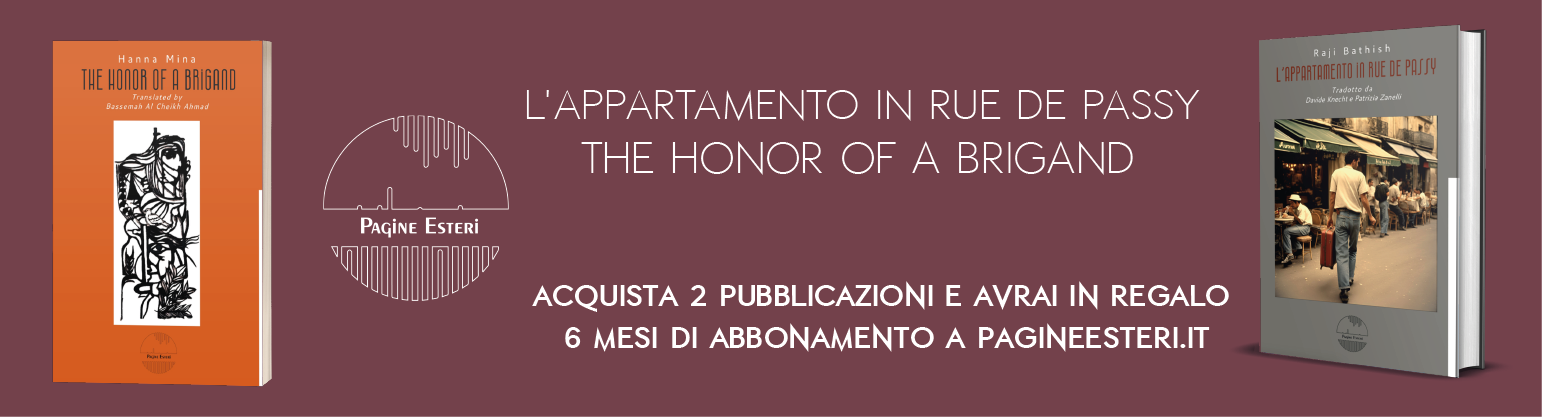di Marco Santopadre
Pagine Esteri, 6 novembre 2024 – Dai tribunali alla Casa Bianca in tempi record. Accusato – e in alcuni casi condannato – di una sessantina di reati, compreso quello di aver incitato una folla di estremisti di destra e complottisti ad assaltare il Campidoglio di Washington il 6 gennaio del 2021 per impedire l’insediamento di Joe Biden, il tycoon è risorto dalle proprie ceneri. In pochi mesi ha sbaragliato gli ambienti repubblicani ostili – alcuni dei quali sono addirittura passati dalla parte di Kamala Harris – e ha espugnato la Casa Bianca ottenendo una delle vittorie più rapide e nette nella storia delle presidenziali statunitensi degli ultimi decenni.
Non ha avuto bisogno di chiamare i suoi alla rivolta, temendo la quale l’ultimo tratto della campagna elettorale e il voto di ieri si sono svolti in un clima di militarizzazione senza precedenti.
A poche ore dall’inizio dello spoglio era chiaro che, sulla mappa elettorale degli states, a prevalere sarebbe stato il rosso di Donald Trump.
Una volta ancora sono stati smentiti tutti i sondaggi, che da quando la vicepresidente ha sostituito un non più spendibile Joe Biden hanno dato sempre la candidata democratica in testa, anche se con un margine troppo ristretto per rassicurare i liberal.
Più di qualcuno aveva avvertito che le rilevazioni erano falsate dal fatto che una parte di coloro che avevano deciso di scegliere Trump, spesso reduci da una serie di voti per i democratici, non rispondevano in modo sincero alle domande dei sondaggisti. Come capita anche in Europa, inoltre, gli istituti demoscopici non sembrano più in grado di dare il giusto peso a fenomeni politici – come appunto il populismo di destra e le pulsioni reazionarie che assumono forme inedite – che nella società viaggiano a lungo sottotraccia prima di emergere in maniera dirompente.
Donald Trump ha vinto negli stati tradizionalmente repubblicani, ma soprattutto in quegli “swing state” – quelli dove tradizionalmente i due schieramenti si equivalgono – dove la vicepresidente in carica sperava di spuntarla, seppur di misura.
E invece, come era evidente alla vigilia, Harris non ha convinto, abbandonata da una quota record di latinos, afroamericani e arabi, divisi tra chi la giudica troppo morbida nel difendere i loro diritti e quanti invece hanno scelto di votare per un razzista e un classista conclamato pur di dare fiducia ad un candidato in linea con le proprie convinzioni ideologiche conservatrici o reazionarie.
Già la diserzione di alcuni importanti sindacati di fede tradizionalmente democratica lasciava presagire che, anche più di otto anni fa, una quota record di membri – soprattutto maschi – della working class bianca avrebbe scelto la demagogia dell’uomo che promette di mettere le cose a posto con la bacchetta magica.

Kamala Harris, con il suo goffo tentativo di coccolare le classi medie e di blandire al tempo stesso i ceti popolari, non è mai entrata in partita e non è mai stata sufficientemente convincente né su un fronte né sull’altro. Partita con un programma vago che voleva però dare l’impressione di una svolta progressista, l’ex procuratrice ha progressivamente imposto una svolta a destra del suo discorso, rincorrendo le posizioni di Trump man mano che i sondaggi ne attestavano la popolarità. L’amministrazione Biden e i messaggi più recenti di Harris hanno finito per dare ragione alle argomentazioni del miliardario inasprendo le leggi sull’immigrazione e confermando i dazi sulle merci cinesi.
L’establishment statunitense tradizionale (in linea con quanto avviene nel resto dell’occidente) sembra ormai non più in grado di ricomporre una frattura interna ed internazionale, scalzata da una nuova generazione di ricchissimi – non a caso Trump ha avuto il fondamentale sostegno di Elon Musk ma anche quello, seppur più sfumato, di Jeff Bezos – che non si accontentano più di governare dalla seconda fila.
In tanti, abbandonati dall’assenza di diritti e tutele ad una lotta tra poveri sempre più feroce per la sopravvivenza, hanno votato Trump con entusiasmo e speranza, animati da un’idea reazionaria e delirante dei rapporti sociali e internazionali e da un desiderio impellente di regolare i conti con i nemici interni ed esterni, abbandonando regole e mediazioni. A nulla è valsa la mobilitazione delle star della musica o il martellante appello a scegliere il “bene” contro il “male”, una classificazione difficilmente conciliabile con l’esperienza concreta e la percezione di settori sempre più ampi dell’elettorato.
Molti altri si sono invece lasciati trasportare dalla paura. Innanzitutto dalla paura del declino della principale superpotenza mondiale, ormai circondata da un numero crescente di potenze regionali e internazionali che reclamano il loro posto al sole e non sono più disponibili a subire i diktat di Washington.
Harris prometteva di ristabilire i tramontati vecchi equilibri internazionali dentro una cornice classica di concertazione internazionale, continuando ad esercitare quel ruolo di primus inter pares che gli Stati Uniti sono sempre stati, almeno nell’ultimo secolo.
Ma quegli equilibri ormai sembrano definitivamente saltati, e la mano dura agitata da Trump nei confronti tanto dei nemici quanto degli alleati – ad esempio quelli europei più volte definiti “scrocconi” – ha riscosso evidentemente più consensi, insieme alle sue ricette protezioniste che promettono di mettere la Cina all’angolo e di rimettere l’Unione Europea al posto suo.
Chi spera che il tradizionale isolazionismo repubblicano raffreddi le tensioni internazionali – in primis quella guerra in Ucraina che Trump ha più volte promesso di fermare in un giorno – rischia di rimanere deluso.
Washington non può permettersi di rimanere con le mani in mano mentre il resto del mondo alza la testa e si ribella accelerando il declino dell’influenza economica, politica e militare statunitense.
Ammesso che la consonanza ideologica tra Trump e Putin (sempre che due potenze governate all’insegna del nazionalismo e dello sciovinismo possano coesistere) possa bastare a congelare lo scenario ucraino, non è un mistero che il tycoon e i settori più reazionari del capitalismo americano considerano una priorità bloccare l’ascesa economica e militare della Cina, ritenuta il principale avversario di Washington nello scacchiere mondiale. La bomba ad orologeria di Taiwan è innescata da tempo, capace di innescare un conflitto mondiale che lo scontro sempre più diretto tra Mosca e la Nato ha da tempo inaugurato. I deliri incendiari del miliardario e del suo vice Vance non sono per niente rassicuranti.
Per non parlare di quel Medio Oriente dove Trump promette un sostegno ad Israele ancora più totale di quello garantito dai democratici e non fa mistero di voler togliere di mezzo l’Iran e l'”asse della resistenza” senza tanti complimenti, sperando di imbarcare anche la “Nato sunnita”.
Occorrerà vedere quanto il Pentagono e le lobby economico-finanziarie trasversali ai due principali schieramenti politici statunitensi vorranno e potranno influire sull’azione del prossimo governo. Ma innegabilmente la vittoria di Donald Trump contribuisce sensibilmente a precipitare le relazioni internazionali ed a drammatizzare una polarizzazione ideologica interna all’occidente che potrebbe presto mettere fine, e per sempre, al mondo come lo abbiamo finora conosciuto. Pagine Esteri
 * Marco Santopadre, giornalista e saggista, già direttore di Radio Città Aperta, è un analista dell’area del Mediterraneo, del Medio oriente e dell’Africa. Scrive anche di Spagna, America Latina e movimenti di liberazione nazionale. Collabora con Pagine Esteri, il Manifesto, El Salto Diario e Berria
* Marco Santopadre, giornalista e saggista, già direttore di Radio Città Aperta, è un analista dell’area del Mediterraneo, del Medio oriente e dell’Africa. Scrive anche di Spagna, America Latina e movimenti di liberazione nazionale. Collabora con Pagine Esteri, il Manifesto, El Salto Diario e Berria