di Patrizia Zanelli*
Pagine Esteri, 4 aprile 2023 – “Fa molto caldo sul ponte. Una goccia di sudore. Scivola dalla fronte alla montatura degli occhiali, poi sulle lenti. Il calore offusca quello che vedo, che mi aspetto di vedere, che ricordo. Mi guardo attorno, e questo luogo si confonde con le immagini di tutta una vita, trascorsa per lo più aspettando di ritornare. Attraverso il fiume Giordano. Il legno del ponte scricchiola sotto i miei passi. Sulla spalla sinistra porto una piccola sacca. Cammino verso ovest in modo naturale, ma solo in apparenza. Dietro di me il mondo, davanti a me il mio mondo”.
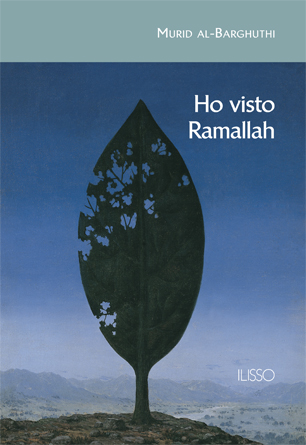 Il poeta palestinese Murid al-Barghuthi (1944-2021) inizia a raccontare così, in Ho visto Ramallah [1], il suo ritorno in Palestina dopo un lungo esilio. L’autore in effetti ripercorre a ritroso la storia della sua vita, spostandosi tra due mondi, in questo romanzo autobiografico, per cui vinse nel 1997 la “Medaglia Nagib Mahfuz”, prestigioso premio letterario istituito dall’Università Americana del Cairo.
Il poeta palestinese Murid al-Barghuthi (1944-2021) inizia a raccontare così, in Ho visto Ramallah [1], il suo ritorno in Palestina dopo un lungo esilio. L’autore in effetti ripercorre a ritroso la storia della sua vita, spostandosi tra due mondi, in questo romanzo autobiografico, per cui vinse nel 1997 la “Medaglia Nagib Mahfuz”, prestigioso premio letterario istituito dall’Università Americana del Cairo.
Evento storico cruciale del racconto è la guerra lanciata da Israele il 5 giugno del 1967, per occupare i territori palestinesi di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza, le alture siriane del Golan e la Penisola del Sinai egiziana. Allora laureando in Letteratura Inglese presso l’Università del Cairo, al-Barghuthi scoprirà di essere improvvisamente diventato esule. Poi vivrà in esilio in più paesi. Riuscirà a tornare in Palestina soltanto nell’estate del 1996 grazie agli Accordi di Oslo (1993 e 1995) che, però, lui stesso aveva da subito considerato inadatti a garantire una soluzione giusta e permanente del conflitto mediorientale. Ne ha la conferma appena arriva nel suo paese:
“Allora, sono questi i “territori occupati”! Questo luogo non è più un’espressione usata in un notiziario, puoi vederne chiaramente la terra, i sassi, le colline e le rocce. Questo luogo ha i suoi colori, una temperatura e arbusti che crescono spontanei…
Finalmente entro in Palestina, ma cosa sono tutte queste bandiere israeliane?”.
Via via deluso da quello che vede lungo il tragitto verso Ramallah, l’autore fa una riflessione generale, come se si rivolgesse alla sua gente, ricorrendo alla tipica autoironia: “Dal ’67 in poi tutto quello che abbiamo fatto è stato “temporaneo”, e sarebbe durato finché le cose non si fossero risolte. E ancora oggi, dopo trent’anni, niente è risolto!… Nel 1948, in seguito alla Nakba, la fondazione dello Stato d’Israele, i profughi si stabilirono nei paesi vicini come soluzione “temporanea”. Lasciarono le pentole sul fuoco sperando di tornare dopo qualche ora! Si dispersero nelle tende e in campi di lamiere di zinco e stagno “temporaneamente”… Abbiamo elaborato programmi di liberazione basati su tappe “temporanee”, ci hanno detto di avere accettato gli accordi di Oslo “temporaneamente”, e così via…”
Nella stessa riflessione al-Barghuthi denuncia chiaramente l’illusorietà di un processo di pace fallito in partenza, essendo sponsorizzato da Washington a sostegno di Tel Aviv, e che di fatto si traduce nella continuazione della Nakba. L’autoironia ravviva inoltre lo stile narrativo perlopiù asciutto e lineare, talvolta crudo, quasi giornalistico, tipico della non-fiction, adottato dall’autore per scrivere Ho visto Ramallah, un testo letterario affascinante e coinvolgente per il miscuglio di sentimenti che trasmette e perché la voce narrante è quella di un grande poeta che descrive la vita reale di persone vere. Nella prefazione del libro, Edward Said (1936-2003) nota anzitutto la concisione e la poeticità del racconto che definisce come “uno dei migliori resoconti personali sulla diaspora palestinese che siano mai stati scritti”. Del resto, anche lui aveva raccontato, in un saggio, il suo ritorno in Palestina, e precisamente a Gerusalemme, dopo un lungo esilio [2].
Munito di un permesso temporaneo per visitare i territori occupati da Israele, durante il breve soggiorno in Cisgiordania, al-Barghuthi ricorda la propria vita intrecciata a quella del suo popolo:“L’occupazione ci ha costretto a rimanere nel passato. Ecco la sua grave colpa: non ci ha privato dei forni d’argilla di ieri, ma della curiosità di sapere cosa avremmo potuto inventare un domani.”

Il futuro negato della Palestina, sottolinea Monica Ruocco, è infatti il problema centrale affrontato da al-Barghuthi in Ho visto Ramallah. L’opera spiega inoltre bene il significato della parola ghurba, usata per indicare la lontananza dalla patria, l’esilio, lo stato psicologico di chi vive una situazione del genere e che, per il poeta palestinese, è come la morte: “La gente crede che tocchi soltanto agli altri. Quell’estate diventai lo straniero che avevo sempre creduto fosse qualcun altro.”
Una volta laureato, al-Barghuthi raggiunge alcuni parenti in Kuwait dove rimane per un paio d’anni. Poi torna al Cairo per sposare, nel 1970, la fidanzata egiziana Radwa Ashur (1946-2014) – che aveva conosciuto all’università -, futura scrittrice femminista, critica letteraria e accademica famosa. Nel 1972, mentre insegna e lavora per l’emittente radiofonica Filasṭīn (Palestina), il poeta pubblica la sua prima raccolta di poesie. Nel giugno del 1977, diventa padre di Tamim, ma, come altri attivisti palestinesi perseguitati dal regime di Sadat, dopo appena cinque mesi sarà espulso dall’Egitto, vivendo poi un secondo esilio. Accolto dall’Ungheria come rappresentante dell’Olp, riuscirà a tornare al Cairo soltanto nel 1994.
In Ho visto Ramallah, l’autore parla di questa lunga lontananza dalla moglie e dal figlio, inframmezzata dai periodi di vacanza in cui loro andavano a trovarlo a Budapest. Nel romanzo, infatti, unisce l’assenza dalla Palestina alla presenza in Palestina, suggerendo che ognuna delle due situazioni è implicita nell’altra nella vita dell’esule; spiega così appieno il senso della ghurba che per lui è una condizione definitiva dell’anima; descrive un dolore che sembra sfumarsi in una malinconia sempre nascosta in fondo al cuore. L’autore riscopre di fatto il suo paese con lo sguardo meravigliato – ma non distaccato – di uno straniero durante quel viaggio fitto di incontri con amici, parenti e intellettuali impegnati in un lavoro di resistenza culturale, come il grande poeta Mahmud Darwish (1941- 2008); e ricorda man mano il passato, per spiegare quello che prova mentre conosce direttamente il presente della sua gente sotto l’occupazione militare israeliana:
“Israele chiude un’area qualsiasi quando vuole. Le persone non possono entrare e uscire, se non quando viene meno il motivo della chiusura, ma di motivi se ne trovano sempre. Vengono alzate barriere tra una città e l’altra. Qui ho sentito la parola mahsom per la prima volta. Vuol dire ‘barriera’ in ebraico. La nascente sensazione di libertà è temporanea.”

Nel romanzo, l’autore denuncia sia le azioni dell’occupante israeliano sia le scelte e l’arroganza dei dirigenti palestinesi; insiste infatti sull’illusorietà del processo di pace di Oslo: “Quando sentite qualcuno pronunciare da una tribuna l’espressione «smantellare gli insediamenti», fatevi una bella risata. Non sono fortezze fatte da bambini con il Lego o il Meccano. Le colonie sono di per sé Israele. Sono l’idea, l’ideologia, la geografia, un imbroglio, una delle tante trovate di Israele. Sono il luogo che ci apparteneva e che hanno fatto loro. Gli insediamenti sono le loro scritture nella loro forma originaria. Sono la loro Terra promessa. Sono la nostra assenza. Gli insediamenti sono la diaspora palestinese”.
In altri brani, l’autore esprime un misto di rabbia e amarezza nell’osservare la deturpazione del paesaggio tradizionale della Palestina, caratterizzato dall’armonia tra natura e architettura. Ora, invece, lo vede deformato per via delle azioni volute dallo Stato occupante, Israele, in linea con la sua politica di Apartheid volta a impedire ai palestinesi di costruirsi un futuro nel loro stesso paese: colonie sparse a macchia di leopardo, check-point ovunque, segni delle distruzioni compiute dall’esercito e così via.
D’altro canto, nel romanzo, al-Barghuthi descrive anche momenti belli e divertenti della propria vita, inclusi quelli vissuti nel seppure breve soggiorno in Palestina. Torna nel villaggio in cui era nato, Deir Ghassana, ricorda quando a sette anni si era trasferito con la famiglia da lì a Ramallah, allora un sobborgo di Gerusalemme. Descrive un matrimonio, con canti, e in particolare, un giovane che danza la dabka; i caffè; una serata poetica e altro. Nel testo include anche alcune delle sue poesie.
Ma durante quel viaggio non riesce a tornare a Gerusalemme: l’esercito israeliano aveva chiuso ogni accesso alla città. Per presentarla, nel romanzo, l’autore anzitutto la spoglia dei suoi simboli per restituirla alla realtà, rendendola viva. Raccoglie i propri ricordi personali di un’esistenza umana normale; con una modalità quasi cinematografica propone una carrellata di immagini di spazi e oggetti, descrive soprattutto una miriade di persone, di attività, di sensazioni ed emozioni, riuscendo a spiegare l’importanza esistenziale, affettiva e identitaria di questa città per il popolo palestinese: “La Gerusalemme che il mondo conosce è la capitale delle religioni, della politica, dei conflitti. Il mondo non conosce la nostra Gerusalemme, quella della gente […] Questa è la città dei nostri cinque sensi, dei nostri corpi e della nostra infanzia. La Gerusalemme in cui camminavamo senza fare troppo caso alla sua sacralità, perché vivevamo lì. E lei era noi”.
Ho visto Ramallah è un romanzo realistico, privo di sentimentalismi e tuttora attuale, perché l’autore presenta le mille sfumature del dolore palestinese, senza banalizzarlo né idealizzarlo, rivelandone tutta l’umanità. Descrive la vita reale della sua gente, parlando di morte, violenza e oppressione, ma anche di amore, bellezza e voglia di vivere. Nel 1998, inoltre, al-Barghuthi tornò di nuovo in Palestina con il figlio Tamim – adesso un poeta e accademico noto -, per fargli conoscere direttamente il suo paese. L’autore racconta anche quel viaggio, in Sono nato lì. Sono nato qui [3], un altro romanzo autobiografico o complemento di Ho visto Ramallah. Nel 2000, al-Barghuthi vinse il più importante premio letterario palestinese per la poesia. La sua intera opera rientra in una vasta testimonianza letteraria della Storia del popolo della Palestina che, come si sa e come conferma Edward Said, “non è un posto qualunque”. Pagine Esteri
NOTE
[1] Murid al-Barghuthi, Ho visto Ramallah, tr. Monica Ruocco, Ilisso, 2005.
[2] Edward Said, Tra guerra e pace: ritorno in Palestina-Israele, tr. Giovanna Bettini e Maria Antonietta Saracino, Feltrinelli, 1998.
[3] Murid al-Barghuthi, Sono nato lì. Sono nato qui, tr. Enrica Preti, Edizioni Q, 2021.
*Patrizia Zanelli insegna Lingua e Letteratura Araba all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È socia dell’EURAMAL (European Association for Modern Arabic Literature). Ha scritto L’arabo colloquiale egiziano (Cafoscarina, 2016); ed è coautrice con Paolo Branca e Barbara De Poli di Il sorriso della mezzaluna: satira, ironia e umorismo nella cultura araba (Carocci, 2011). Ha tradotto diverse opere letterarie, tra cui la raccolta poetica Diario della Rivoluzione (Lushir, 2011) del poeta tunisino Mohammed Sgaier Awlad Ahmad, e il romanzo Atyàf: Fantasmi dell’Egitto e della Palestina (Ilisso, 2008) della scrittrice egiziana Radwa Ashur. Ha curato con Sobhi Boustani, Rasheed El-Enany e Monica Ruocco il volume Fiction and History: the Rebirth of the Historical Novel in Arabic. Proceedings of the 13th EURAMAL Conference, 28 May-1 June 2018, Naples/Italy (Ipocan, 2022).





















