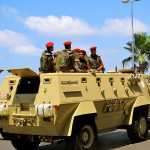di Pietro Basso –
Pagine Esteri, 29 marzo 2024. “Non sono le pallottole ad uccidere, è il silenzio”, ha scritto Muhammad Taha. Se ciò è vero, è benvenuta quest’opera prima di Valeria Roma (“Ignorare l’assenza. La letteratura palestinese nell’immaginario italiano” Meltemi editore), che non rispetta l’imperativo di coprire di silenzio la vita quotidiana, la lotta, la cultura, la causa dei palestinesi. E ci fornisce una guida critica essenziale, ordinata senza pedanteria, dalla scrittura asciutta ed elegante, che finora mancava, della letteratura palestinese in lingua italiana, e del suo contributo al rinnovamento di una letteratura italiana da tempo raggrinzita nel provincialismo.
Il toro – la pretesa del sionismo di cancellare il passato e il presente della Palestina e dei palestinesi per escludere che possano mai avere un futuro – è subito preso per le corna. Una postura necessaria specie in tempi come questi in cui impazza, dentro e fuori Israele, un sionismo a tal punto intriso di fanatismo religioso da mettere in discussione perfino la possibilità di una coesistenza pacifica tra le stesse “quattro tribù” ebraiche (di cui ha parlato Rivlin). Un sionismo a tal punto preda della sua auto-esaltazione da pretendere di avere chiuso una volta per tutte la “questione palestinese” con il proclamare Israele “lo stato degli ebrei”, legittimando a posteriori e, nel contempo, a priori la pulizia etnica compiuta, e da ultimare, ai danni del popolo palestinese.
Sennonché questa pretesa, che la hasbarà rilancia pure in Italia con illimitato fanatismo e altrettanto illimitata libertà d’azione, urta contro la coriacea realtà di un’esistenza sociale piena di ferite e di mutilazioni, ammanettata, umiliata, dispersa, e tuttavia irriducibile a semplice ammasso di polvere del deserto. Certo: un secolo di colonizzazione ha mutato in modo radicale ambiente, demografia, rapporti sociali della Palestina. Qualunque esule torni alla ricerca del mondo di ieri, o almeno delle sue tracce, finisce per restare, immancabilmente, deluso. Ma questa esistenza sociale rinasce di continuo dalle sue ceneri come l’araba fenice. Si rinnova, ringiovanisce, urla periodicamente la sua rabbia e il suo desiderio di libertà e di riscatto con le sue sollevazioni di massa (sono già quattro da quel fatidico 8 dicembre 1987). Parla di sé, a sé e al mondo intero, con la letteratura.
Il prezioso lavoro di Isabella Camera d’Afflitto e di altre studiose e studiosi capaci di un’attitudine exotopa scevra da sentimentalismi ha presentato anche ad un pubblico che non ha conoscenza della lingua araba la grande ricchezza e varietà di generi della letteratura araba contemporanea. “Svegliatevi Arabi! In piedi! / Su dal fango che fino al ginocchio vi serra. / Perché vi appoggiate a speranze che son tradimento, / se già vi attanaglia la morte? / Dio è il più grande, cos’è questo sonno? / Orsù, fuori dal vostro giaciglio, nel turbine entrate”, aveva intimato (nel 1913) il poeta libanese Ibrahim al-Yazigi. Non ha gridato invano. Si può constatarlo pure da questa rassegna che si muove nel solco appena indicato. E lo fa con mano sicura, senza risparmiare meritate stoccate a mostri sacri quali Pier Paolo Pasolini, e distinguendo in maniera opportuna gli scrittori o le scrittrici di maggior successo da quelli/e di maggior valore.
L’autrice ha scelto di presentare le singole opere letterarie come altrettante tessere di un mosaico che via via si completa con “gli oggetti, le tradizioni, i giochi, ma anche le macerie della Palestina dimenticata”. La quotidianità che ne emerge è inevitabilmente punteggiata di caserme, demolizioni, assassinii, pogrom, sofferenze, discriminazioni, pervasa da un’ansia permanente che sconfina nell’angoscia, se non nella disperazione, quando il servilismo degli sconfitti divenuti obbedienti diventa norma di comportamento fino alla delazione, e tutto, proprio tutto, appare perduto. Come se l’avverso destino avesse riservato alla Palestina e ai palestinesi nient’altro che una catena di nakbah e di naksah.
Sull’intero quadro grandeggia la guerra. Una guerra infinita, in cui si è trattati da “infiltrati”, e ci si sente profughi, nella propria terra di nascita. Una guerra, a cui non ci si può sottrarre neppure con l’esilio. Una guerra a cui non si vogliono sottrarre i coraggiosi, le coraggiose, nei quali/nelle quali la collera periodicamente esplode sprigionando con una forza ogni volta nuova il desiderio, il sogno collettivo di liberazione. Ma se la stessa continuità dell’esistenza è un modo di resistere, allora anche le “armi passive”, le abbondanti riserve della memoria, la malinconia, la nostalgia (gurbah), l’auto-ironia, il sarcasmo, possono arginare il senso di straniamento che incombe, e arrivare a fendere, piccoli raggi di luce, il buio fitto che impedisce di intravvedere l’uscita, quando e come che sia, dall’enorme carcere a cielo aperto che è ormai diventata l’intera Palestina storica, e non soltanto la striscia di Gaza.
Nelle sue differenti articolazioni di letteratura dei territori occupati, racconti dell’esilio, del ritorno e del carcere, letteratura impegnata (i grandi nomi di Kanafani e Habibi), letteratura fantascientifica, per l’infanzia e perfino noir, la letteratura palestinese è presentata qui come una forma di resistenza alla macchina dell’oppressione israeliana. Se l’occupazione e l’espropriazione della Palestina è stata ed è insieme fisica e metaforica, allora la scrittura esprime la reazione di un corpo sociale, di tanti corpi-menti individuali, vivi e capaci di creatività, liberi anche nella più snervante prigionia. Così, attraverso le parole, una lingua che sfida di continuo i padroni del carcere e i loro volonterosi complici, la Palestina e la causa dei palestinesi rinascono, rispuntano di continuo, a sorpresa, da sotto le macerie dei bulldozer incaricati di spianarla. Nella sua pungente polemica con l’“ipotesto sionista” che declassifica i palestinesi ad altrettanti calchi immodificabili e omogenei di un’atavica arretratezza “di razza”, Valeria Roma ha inteso mostrare come nell’esperienza sociale palestinese ci sia spazio, invece, per le aspirazioni e le differenze individuali, per una modernità che si colloca oltre lo spirito gregario del clan senza per questo dissolvere i legami comunitari.
Il valore di tale polemica fuoriesce da questa specifica materia, dacché la “grande narrazione sionista” su Israele, sulla Palestina, sul popolo palestinese, rappresenta il tipo più estremo ed intransigente di revisionismo storico in chiave etnocratica in circolazione. Come ha osservato E. Said occupandosi della questione palestinese, “in Occidente pressoché l’unico gruppo etnico verso il quale è tollerata, se non incoraggiata la denigrazione a sfondo razziale, è quella araba”. E non v’è dubbio che quando la grancassa della propaganda anti-palestinese insiste sul “terrorismo” dei palestinesi, è degli arabi in generale che si parla. Ma io sono convinto che non si tratti solo degli arabi, né di tutti gli arabi presi in blocco al di là delle profondissime differenze di classe che segnano le società arabe. Nell’incredibile fortuna e diffusione che l’ideologia anti-palestinese ha nel mondo occidentale odierno, e non solo, la Palestina e i ribelli palestinesi sono un simbolo di un “qualcosa”, di un pericolo, ancora più ampio.
“Cerco la vera Palestina, la Palestina che vale più dei ricordi, più di una penna di pavone”, fa dire Ghassan Kanafani al suo Said in Ritorno ad Haifa. Ed escludendo che la vera Palestina possa essere quella di un tempo irrimediabilmente passato, formula la domanda bruciante: cos’è, dov’è la vera Palestina oggi? Questa rassegna ci aiuta a capirlo. Non saremo mai abbastanza grati alla sua autrice e ai traduttori delle opere che ha recensito per averlo consentito. La Palestina e i palestinesi, afferma Aysar al-Saifi, sono “un seme, un viaggio, un campo e una lettera”, facendo eco al poeta algerino Malek Haddad: “Je suis chez moi en Palestine”. La Palestina come luogo del cuore. La Palestina, allarga lo sguardo Mahmoud Suboh, è un “universale fantastico”, “racchiude nella sua storia tutte le particolari resistenze nel mondo, come Omero voce della collettività del popolo greco”. Ma se, ad onta del falso antagonismo tra democrazie e autocrazie, davvero “il male del nostro tempo è la perdita della libertà” ovunque (Walid Daqqa), la Palestina e i palestinesi – lungi dall’essere stati cancellati dalla storia – esprimono, nella loro semplice esistenza, e tanto più nella loro ribellione, la voce, il grido di dolore, la speranza delle masse oppresse del mondo intero.
Con i versi di un poeta napoletano: “c’è una musica di fanfare, del grande esercito coloniale” (ci spacca i timpani ogni giorno), e “c’è una musica della terra, del Sud che si ribella”… Qui terra non è solo agricoltura: ulivi, cotone, sesamo, fichi, agrumi, mandorle, nespole, orzo, rose, gelsomino, che pure tanta parte hanno nella letteratura palestinese. È terra come fonte della vita e della strenua difesa della vita della natura e della specie umana dalla brutale pretesa totalitaria dell’industria del controllo carcerario, della dazione di morte, del distruttivo colonialismo “ecologista”, in cui per sua stessa sventura si è specializzato lo stato “ebraico”, avanguardia tecnico-politica, educatore e fornitore di tutti gli apparati statali capitalistici del Nord e del Sud, dell’Est e dell’Ovest. Ai nostri giorni, infatti, la guerra, l’economia di guerra, la disciplina di guerra grandeggiano non più soltanto sulla Palestina storica, incombono sull’intero globo con le loro apocalittiche minacce. Palestina, allora, è il mondo. E la sua letteratura è entrata da tempo, non a caso, nella letteratura del mondo. Ma di quale mondo si parla? E quale futuro per questo mondo?
Al momento per la “questione palestinese” non è in vista alcuna soluzione. All’oggi l’intera storia della lotta secolare dei palestinesi per la propria liberazione può apparire come un seguito di occasioni mancate, di insuccessi, di sconfitte, di tradimenti. Nonostante ciò, è questo che inquieta le élite globali, la questione palestinese resta aperta. La resistenza palestinese, in sempre nuove e articolate forme, di cui la letteratura non è certo l’ultima, è viva. E continua a riscuotere simpatia e solidarietà nel mondo intero da parte di tutti/e coloro che odiano l’oppressione delle nazioni, il colonialismo vecchio e nuovo, l’apartheid, il razzismo, il militarismo – tratti essenziali dell’odierno stato di Israele. Non lo dico io: lo sostengono gli intellettuali ebrei e israeliani più illuminati, quali N. Chomsky e I. Pappe. Lo dicono anche quei giovani cittadini di Israele – per pochi che essi siano – che condannano i pogrom e si rifiutano di servire nell’esercito.
Non è solo per una ragione di ordine demografico che la questione palestinese resta aperta. Resta aperta come questione nazionale e, sempre più, come questione sociale. Nazionale perché la resistenza palestinese rende evidente l’ingiustizia di un popolo senza stato; sociale, di date classi sociali, perché si è creato in questi decenni uno strato di borghesi e burocrati palestinesi benestanti, privilegiati collusi con Israele, mentre la grande massa proletaria e semi-proletaria dei palestinesi di Gaza, della Cisgiordania, della diaspora dei campi profughi, dei palestinesi cittadini di Israele, vive in condizioni di atroce povertà e deprivazione (è l’80%!), e deve affrontare soprusi e tormenti di ogni tipo.
Il richiamo all’unità che negli ultimi anni è salito dalle piazze palestinesi non è tanto, secondo me, un richiamo all’unità delle rappresentanze politiche storiche, sempre più indebolite e prigioniere dei propri vincoli con Israele, i governi occidentali e/o le petrolmonarchie, quanto un richiamo all’unità degli strati più oppressi, diseredati, impoveriti. Quelli che, insieme ad una parte della gioventù istruita senza lavoro, hanno riempito le piazze in tanti paesi del mondo arabo nelle due ondate di sollevazioni del 2011-2012 e del 2018-2020.
A questo riguardo Maher Charif ha parlato di “gruppi sociali popolari che hanno fatto irruzione, per la prima volta in questa forma, sulla scena dell’azione politica” gridando “pane, dignità e giustizia sociale”, e fissando un obiettivo ancor più alto e radicale: “il popolo vuole abbattere il regime”. Nonostante il loro provvisorio scacco, questi avvenimenti hanno messo in luce che non esiste solo un mondo arabo, ne esistono due sempre più distanti ed estranei: il campo delle classi dominanti, in vario modo legate all’ordine mondiale capitalistico, e il campo delle classi sfruttate. Per la Palestina e i palestinesi le cose si stanno muovendo in questa stessa direzione, da decenni. E poiché la spaccatura in profondità di tutte le società – anche di quelle più ricche, come gli Stati Uniti e l’Europa – è un dato universale, ecco che si sono create le condizioni affinché il messaggio di lotta delle masse oppresse e sfruttate della Palestina e del mondo arabo arrivi molto lontano.
Questo studio dimostra che, anche attraverso la letteratura, il messaggio è arrivato perfino nella torpida Italia, presentandoci una “identità palestinese” in continua trasformazione, che si sottrae alle “etichette semplificatorie e discriminanti della nazionalità, della cittadinanza, dell’appartenenza religiosa” per assurgere a significati di maggior respiro e profondità, una Palestina agente in Italia. Per paradosso, lo sforzo sistemico messo in atto per desertificare la “questione palestinese”, per “spogliarla della sua sacralità” riducendola a semplice affare di procedure amministrative (Murid al-Barghuthi), si sta rovesciando nel suo contrario, e la investe di una forza simbolica eccezionale. La Palestina è ovunque. Ovunque sia assente la libertà per la presenza dei meccanismi di sfruttamento e di dominio che stanno togliendo il respiro alla classe lavoratrice di tutte le razze, le nazionalità, le religioni o le non-religioni, e alla stessa natura. Ovunque si lotti senza paura per liberarsi da questi meccanismi universali. Senza cessare di essere la Palestina storica nella drammatica concretezza del suo presente, Palestina è il luogo in cui le rose rosse rinasceranno sempre.
Buona lettura.