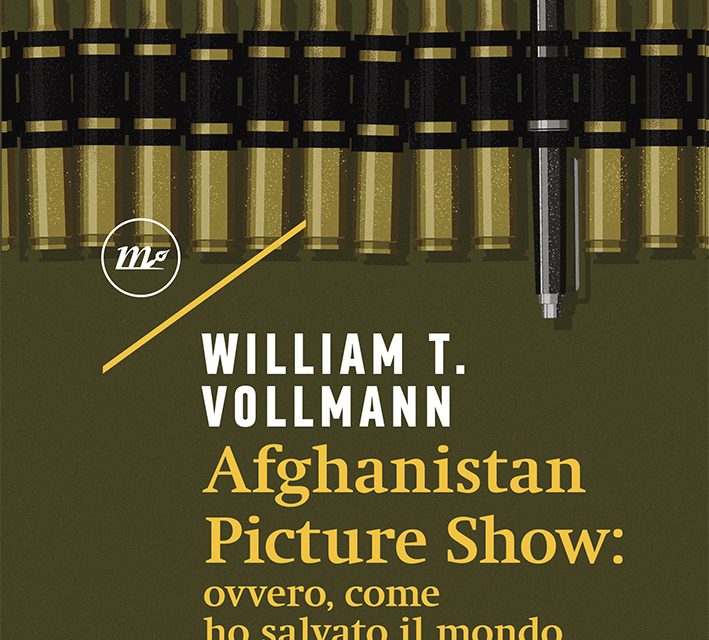di Valeria Cagnazzo
Pagine Esteri, 30 gennaio 2023 – Il termine “umanitarismo” (“humanitarianism” in inglese) indica una dottrina informale che pone la solidarietà e la tutela del bene altrui come obiettivo cardine dell’esistenza umana. Gli uomini sono chiamati da questo imperativo morale ad assistere il prossimo, ad alleviarne le sofferenze e ad accorrere in suo soccorso in caso di emergenza, assecondando i propri sentimenti di empatia e compassione e le proprie aspirazioni di altruismo.
Una vocazione che accomuna senz’altro le organizzazioni non governative e le agenzie di cooperazione internazionale, ma non priva di rischi e criticità. In nome dell’aiuto umanitario, infatti, negli ultimi decenni diverse operazioni militari si sono ammantate di ideologie filantropiche che le giustificassero e ne legittimassero la durata. Senza contare il fatto che l’umanitarismo stesso può recare in sé, pur fondandosi su ideali di uguaglianza, un pericoloso germe post-colonialista: uno sguardo verticale, rivolto dal bianco al nero, dal nord al sud, dal benefattore ricco e colto all’indigente vittima della guerra.
Pur percorrendo un sentiero “lastricato di buone intenzioni”, anche il giornalista, non solo l’”umanitario” di professione, può incorrere in quest’insidia: il rischio è quello di oggettificare l’altro senza conoscerlo, di identificarlo come il bersaglio della propria bontà d’animo privandolo di identità e complessità. Raccontando un fallimento, William T. Vollmann smaschera in questo libro, con straordinaria lucidità, i limiti, i difetti, le ingenuità più o meno perdonabili commesse dalla fortunata società occidentale quando si mette in testa di salvare il mondo.
“Afghanistan Picture Show – ovvero come ho salvato il mondo” è un reportage narrativo, un diario semi-serio, un taccuino disordinato. Restituisce l’esperienza che lo scrittore William T. Vollmann, tra i più acclamati e interessanti autori della scena americana contemporanea, produttore fluviale di migliaia di pagine, come il capolavoro Europe Central (vincitore nel 2005 del prestigioso National Book Award for Fiction), trascorse tra Pakistan e Afghanistan ai tempi dell’occupazione sovietica del Paese. L’opera fu pubblicata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1992, dieci anni dopo la sua stesura, e successivamente in Italia da Alet. Nel 2020, la casa editrice Minimum Fax ne ha fortunatamente prodotto una nuova edizione, nella traduzione di Massimo Birattari.
Non ha neanche ventidue anni Vollmann quando parte alla volta dell’Afghanistan. Per finanziare il suo viaggio, ha lavorato per otto mesi in una compagnia di assicurazioni. E’ un aspirante scrittore animato da grandi ideali e dall’impellente necessità di aiutare una popolazione in pericolo. E’ il 1982 e le truppe sovietiche hanno invaso l’Afghanistan. Le agenzie internazionali descrivono all’opinione pubblica occidentale un Paese sprofondato in una profonda crisi umanitaria: il giovane Vollmann decide allora di lanciarsi in suo soccorso. Si unirà ai mujaheddin, documenterà con le sue fotografie e il suo reportage la loro strenua resistenza e grazie alla sua testimonianza in Occidente ricaverà i finanziamenti necessari a procurare loro le armi per sconfiggere i russi. Questo è il suo piano.
Un progetto funambolico e ingenuo che sintetizza così: “C’era una volta un Giovanotto che voleva essere più di quello che era in realtà. Ciò lo rendeva infelice. Decise di andare in Afghanistan a fotografare le pallottole che gli sibilavano vicino alle orecchie. Purtroppo soffriva di mal di pancia”.
E’ così che il Vollmann “adulto”, che ripercorre in queste pagine il suo vecchio rendiconto, chiama il ventiduenne di belle speranze che voleva salvare l’Afghanistan: il Giovanotto. Un reporter così affascinato dalla lotta dei mujaheddin da essere disposto a imbracciare le armi accanto a loro contro le truppe sovietiche, ma che arrivato in Pakistan inizia a fare i conti con i propri limiti. La dissenteria, in primis, che lo accompagna per l’intero viaggio.

Si capovolge l’immagine del giornalista-guerrigliero alla quale ci hanno abituati George Orwell ed Ernest Hemingway, così a loro agio nel redigere pezzi giornalistici e al tempo stesso nell’imbracciare le armi nella guerra civile spagnola. Qui Vollmann, spinto dalle stesse velleità, scopre la fragilità di un organismo che non riesce ad abituarsi al nuovo clima, al cibo, all’acqua sporca che alimenta incessantemente le sue gastroenteriti. E’ alle prese con un fisico appesantito e impigrito dai vezzi della società ricca dalla quale proviene e che non riesce ad adattarsi ai ritmi di vita degli afghani che gli offrono ospitalità. Di utilizzare un’arma è totalmente incapace.
“Era un fardello”, arriva a dire di sé, quando finalmente i mujaheddin lo accompagnano oltre il confine pakistano in Afghanistan. Ha atteso quel momento con impazienza, lamentandosi dei ritardi come “un bambino viziato”, ribadendo “Io voglio solo aiutarvi, lo faccio per voi, non per me”, per sottolineare l’urgenza della sua missione. Ma arrivati al momento di superare le montagne per arrivare in territorio afghano, il Giovanotto è totalmente impreparato allo sforzo ed è costretto a dipendere dall’aiuto dei guerriglieri, che se lo portano finanche in spalla, mentre senza mangiare e senza bere perché in Ramadan si arrampicano sulle rocce con piedi sanguinanti.
Si lascia offrire Sprite ghiacciate per tutta la durata del viaggio da ospiti che non possono permettersi medicine né scarpe per proteggersi dal freddo. Partecipa ai loro pranzi, si fa preparare uova fritte da mangiare e lascia che colgano grappoli d’uva per lui. La gestione del denaro è un altro curioso punto saliente nella sua “missione”. Deve risparmiarlo, per investirlo al meglio nella “salvezza” di una Nazione. Lo coglie a un certo punto il dubbio che i soldi spesi per il biglietto aereo del suo viaggio verso il Pakistan avrebbero potuto aiutare molte persone in America, senza la necessità per lui di spostarsi inseguendo un ideale filantropico. Non può, però, focalizzarsi su questo dettaglio: il giovane reporter deve “salvare gli afghani”.
Le sue raccolte fondi, una volta rientrato negli Stati Uniti, saranno un fallimento. “Ben presto”, scrive, “avrebbe organizzato le sue presentazioni a sostegno degli afghani, alle quali non sarebbe venuto quasi nessuno”. I guadagni sono così scarsi da poter essere definiti “omeopatici” per la resistenza afghana.
Nonostante le sue debolezze, per tutta la durata della sua missione gli afghani si mostrano sempre generosi nei suoi confronti, accondiscendenti, ogni tanto quasi servili. Come un lampo, nell’ebbrezza del potere salvifico della sua presenza in quel Paese, balena talvolta la fastidiosa percezione di un divario colonialista profondo e spaventoso: “Quest’uomo anziano e rispettabile (il generale di brigata che lo ospita, ndr) si preoccupava di perdere la faccia con un ventunenne che stava male ogni volta che usciva al sole. Perché? Perché il ventunenne era americano”. Oppure, quando i profughi che incontra scoprono che lui non può aiutarli a ottenere un visto per trasferirsi nella sua prospera e felice America, balugina una domanda: “Cos’è la libertà? Cos’è la democrazia?”.
Il giovane Vollmann si rivela disarmato non solo fisicamente nel suo viaggio di reporter umanitario. Tutto quello che sa chiedere ai suoi ospiti e ai profughi afghani sono domande di comica ingenuità, definita spesso innocenza. “Sei felice qui?”, si ritrova a chiedere ai suoi interlocutori. O ancora, registratore alla mano, “Hai qualcosa da dire agli americani?”.
Il Vollmann adulto guarda, però, con nostalgia e tenerezza indulgente a quel comico Giovanotto. “Il Giovanotto aveva un entusiasmo e una fede che io non ho”, scrive, ammettendo di ammirarlo un po’ per il suo desiderio di salvare il mondo “nonostante tutta la sua ignoranza”. In fondo, malgrado le ingenuità del Vollmann-giornalista, questo libro rispetta quella che da allora è rimasta la sua poetica, decodificata nel suo manifesto del 1990 contenuto in “Scrittura Americana Oggi: una diagnosi della malattia”. Sette regole per scrivere, che partono da “Non dovremmo mai scrivere senza sentimento”, alla necessità di “Trattare di problemi umani” e “Cercare una soluzione a quei problemi”, fino a “conoscere il nostro argomento, trattarlo con lo stesso rispetto che l’Io deve all’Altro. Conoscerlo in ogni suo senso, finché gli occhi siano annebbiati dal vederlo, le orecchie fischino dal sentirlo, i muscoli brucino per l’abbracciarlo e le gonadi si infiammino dal farci l’amore”. Fino a soffrire di dissenteria, si potrebbe aggiungere. Per questa trasparenza e fedeltà, per l’acuità di uno sguardo che non si fa sconti, quest’opera dovrebbe essere un vademecum insostituibile nelle mani di tutti gli aspiranti reporter narrativi, e non solo.
A quarant’anni dal reportage di Vollmann, in Afghanistan si annega ancora. Resta, infatti, intatta la consapevolezza del limite – del professionista umanitario, dello scrittore, del reporter – nell’addentrarsi nella sua fitta rete di decenni di violenza e ricavarne una verità. A proposito di questo Afghanistan, Vollmann “si dedica” un epitaffio di Wittgenstein: “Qui è difficile, per così dire, tenere la testa in su”. Che si spiega così: “Vedere che dobbiamo restare fermi alle cose del quotidiano e non imboccare la strada sbagliata, dove ci sembra di dover descrivere estreme sottigliezze, che tuttavia non saremmo affatto in grado di descrivere con i nostri mezzi. E’ come se dovessimo aggiustare con le nostre dita una ragnatela lacerata”.